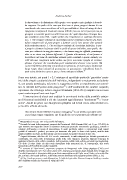Page 16 - Federico Focher (a cura di), PIERRE-LOUIS MOREAU DE MAUPERTUIS Lettere filosofiche e scientifiche
P. 16
Federico Focher
la durevolezza o la distruzione delle spezie: ecco quanto a mio giudizio si dovreb-
be supporre. Se quello ch’io sono per dirvi non vi piace, pregovi almeno di non
considerarlo che come uno sforzo ch’io fo per soddisfarvi. Non mi lusingo di darvi
spiegazioni compiute di fenomeni cotanto difficili; ma non sarà sì poco per me, se
giungerò a connetter questi con altri fenomeni, da’ quali dipendono. Bisogna dun-
que considerar come fatti, i quali sembra che l’esperienza ci costringa d’ammet-
tere. 1. Che il liquor seminale di ciascheduna spezie d’animali contiene una molti-
tudine innumerevole di parti proprie a formare con la loro unione altri animali
della medesima spezie. 2. Che nel liquor seminale di ciaschedun individuo, le par-
ti proprie a formare le fattezze simili a quelle di questo individuo, sono quelle, che
sono per ordinario in maggior numero, e che hanno maggior affinità, quantunque
altre ve ne siano con fattezze differenti. 3. Quanto alla materia, di cui formar si
dovrebbero nel seme di ciaschedun animale parti consimili a questo animale; sa-
rebb’ella una congettura molto ardita, ma forse non tanto spoglia di verisimi-
glianza, il pensare che ciascheduna parte somministrar dovesse i suoi germi. Chi
sa che l’esperienza dilucidar non potesse un tale punto, se si provasse a mutilar per
lungo tempo alcuni animali di generazione in generazione: vedrebbonsi forse le
37
parti recise diminuire a poco a poco, e forse estinguersi affatto.
Dopo aver intuito, nei punti 1 e 2, l’esistenza di specifiche particelle ‘genetiche’ porta-
trici delle singole caratteristiche dell’individuo, indipendenti e mutuamente escludente-
si, con grande perspicacia, nel punto 3, suggerisce perfino un esperimento per control-
38
lare la validità dell’ipotesi della pangenesi e dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti;
esperienze che il biologo tedesco August Weismann (1834-1914) compirà con successo
39
quasi centocinquant’anni anni dopo.
L’osservazione di alcuni casi ereditari lo convincerà inoltre della possibile esisten-
40
za di fenomeni assimilabili a ciò che i genetisti oggi chiamano “dominanza” e “reces-
sività”. Anche in questo caso Maupertuis spiegherà tali eventi con la allora recente sco-
perta delle affinità chimiche.
41
Uno dei più illustri Membri di questa Compagnia, la cui perdita sarà dalle scien-
ze per lungo tempo compianta; uno di quelli che aveva penetrato più addentro ne’
37
Maupertuis (1767, pp. 129-131); corsivi dell’autore.
38
Secondo la teoria della pangenesi, proposta da Darwin nel 1868 (Darwin 1868, vol. 2, pp. 357-404), da
ogni distretto dell’organismo adulto si sarebbero distaccate particelle minutissime (gemmule), serbanti il
carattere dell’organo o tessuto di provenienza, le quali sarebbero andate a concentrarsi negli organi
genitali di entrambi i genitori, per essere poi trasmesse alla prole. In base a tale ipotesi, sarebbe stato
quindi possibile osservare nei figli alcuni caratteri acquisiti dai genitori durante la loro vita.
39
August Weismann, alla fine del XIX secolo, osservando, in ratti sottoposti per diciotto generazioni a
caudotomia, che nella prole la lunghezza media della coda rimaneva invariata, dimostrò l’assenza di
qualsiasi influenza delle cellule somatiche dell’organismo adulto sulle cellule germinali (germoplasma).
Ciò diede il colpo fatale sia alla teoria darwiniana della pangenesi sia, di conseguenza, alla teoria
lamarckiana dell’eredità dei caratteri acquisiti.
40
Il concetto di “dominanza”, vagamente proposto da Maupertuis nella Vénus physique (1745) verrà
ribadito espressamente nel 1752, nella Lettera XVII, Sopra la generazione degli Animali, dove si legge che
l’eredità biparentale è dimostrata dalla «manifesta rassomiglianza del figlio ora al Padre, ed ora alla Ma-
dre, a misura che le parti dell’uno, o dell’altra avranno dominato nella sua generazione» (infra, p. 35).
41
«Il Sig. Geofroy» scrive in nota Maupertuis. Si tratta del già citato Étienne-François Geoffroy, membro
dell’Académie Royale des Sciences di Parigi dal 1699.
XIV