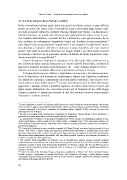Page 76 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 76
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
7.5. L’ultima stagione delle Pratiche criminali
Nella criminalistica italiana degli ultimi due secoli del diritto comune è assai difficile
trovare un autore che riesca, come il civilista De Luca, a svincolarsi dagli schemi eredi-
tati dalla tradizione. Mentre il cardinale venosino dipinge dall’esterno, con franchezza e
libertà d’opinione, un quadro del sistema penale particolarmente critico verso le posi-
zioni assunte dalla dottrina, i penalisti del Sei e Settecento, come già accennato, da un
5
lato oscillano tra sistemazioni dogmatiche basate sul dualismo accusa-inquisizione,
6
sulla tripartizione accusa-denuncia-inquisizione, o sul recupero di suddivisioni ancora
7
più articolate e risalenti, dall’altro si dedicano a opere descrittive dai meri interessi
pratici, nelle quali la specifica attenzione per singoli istituti e per determinati momenti
processuali si inserisce in un panorama casistico dominato da forme inquisitorie consi-
8
derate immutabili e non perfettibili.
Questi orientamenti dottrinali si perpetuano fino alle soglie della codificazione e,
pur convivendo dalla metà del Settecento con i nuovi indirizzi illuministici, mostrano di
ignorare il profondo travaglio anche ideologico che – come vedremo meglio tra breve –
interessa una parte consistente della scienza penalistica nel resto d’Europa.
L’incapacità di proporre effettive e significative innovazioni e la tendenza ad ante-
porre la descrizione alla discussione caratterizzano dunque una letteratura penalistica
9
che manifesta comunque, segnatamente in alcuni ambiti territoriali, una discreta viva-
10
cità e talora un buon livello tecnico. Accanto alla riproposizione di opere del passato
aggiornate e adattate, infatti, è possibile registrare un’ampia messe di lavori nuovi, dal
taglio spesso istituzionale che, ricorrendo sempre più di frequente all’uso della lingua
italiana, ricoprono il sistema processuale di una fitta tessitura casistica senza peraltro
intaccarne le strutture portanti.
5
Questo dualismo si risolve di frequente nella ricerca del criterio distintivo tra procedimenti che devono
essere avviati ex officio e procedimenti che possono essere avviati su istanza o querela di parte. Esemplare
a questo proposito è la Pratica criminale di Domenico Moro (Napoli 1749), avvocato di una certa
notorietà nel foro di Napoli.
6
Accolta ad esempio nelle Institutiones Criminales di Domenico Ursaya (Roma 1701), professore e
avvocato di discreta fama attivo a Roma a cavallo tra Sei e Settecento.
7
Le Institutiones Criminales di Arcangelo Bonifazi (Iesi 1765), titolare di giurisdizioni minori in area
umbro-marchigiana e autore anche di una Pratica civile e criminale (Iesi 1756), enumerano almeno sei
forme diverse di processo penale, rispettivamente fondate su accusa, denuncia, inquisizione, confessione,
eccezione e flagranza.
8
È il caso delle Istituzioni teorico-pratiche criminali di Filippo Mirogli, avvocato fiscale generale a Roma
(Roma 1758-1764). L’opera, basata sull’esperienza professionale dell’autore e caratterizzata da un buon
successo editoriale, prende in esame una dozzina di figure di reato e per ognuna di esse offre una puntuale
descrizione degli adempimenti processuali, alla luce delle possibili varianti e con continui riferimenti ai
verbali dei singoli atti dell’inquisizione.
9 Nei territori della Repubblica di Venezia, ove il procedimento penale assume contorni originali
conservando parecchi elementi del rito accusatorio, ha grande successo fino al XVIII secolo la Prattica
criminale secondo le leggi della Serenissima Repubblica di Venezia, redatta alla fine del XVI secolo da
Lorenzo Priori, cancelliere presso numerose corti a Venezia e in Terraferma, e pubblicata postuma a
Venezia nel 1622.
10 Come nel caso della fortunata Pratica Universale, pubblicata a Firenze nel 1665 da Marc’Antonio
Savelli, giudice e funzionario al servizio del Papa e del Granduca di Toscana, o della Syntaxis rerum
criminalium data alle stampe a Roma nel 1688 da Gian Domenico Rainaldi, uditore del tribunale criminale
del Torrone di Bologna dal 1671 al 1676.
66