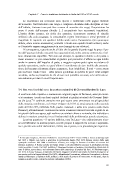Page 73 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 73
Capitolo 7 – Prassi e tradizione dottrinale in Italia dal XVI al XVIII secolo
Le conclusioni ora accennate sono riprese e confermate nelle pagine dedicate
all’accusatio. Nell’introdurre una lunga e complessa disamina della disciplina de iure
dell’istituto, Farinacci non può fare a meno di avvertire che «oggi l’inquisizione ha
preso il posto dell’accusa» («hodie […] accusationis loco successerit inquisitio»).
L’antico diritto comune, sia civile che canonico, riconosceva carattere di rimedio
ordinario alla sola accusatio; la consuetudine è però intervenuta e ormai permette al
magistrato di inquisire «in qualsiasi delitto anche senza l’accusatore» («in quocunque
delicto, etiam nemine accusante»); entrambi i rimedi sono quindi ritenuti ordinari, anche
se l’inquisitio «appare maggiormente in uso» («magis in usu videtur»).
Di conseguenza, e grazie anche al fatto che la querela di parte «oggi ha preso il po-
sto dell’accusa» («hodie successit loco accusationis»), molte annose controversie risul-
tano chiaramente superflue. Tali sono ad esempio le questioni relative a chi possa o
meno accusare: se per consuetudine il giudice può procedere d’ufficio in ogni delitto
anche in assenza dell’impulso di parte, a maggior ragione potrà agire «su istanza di
qualche accusatore, anche se quest’ultimo è considerato de iure inabile alla presenta-
zione dell’accusa» («instante aliquo accusatore, licet inhabilis»). E anzi – come aveva
già osservato Giulio Claro – nella pratica quotidiana la querela di parte viene sempre
accettata, anche se presentata da chi de iure non potrebbe accusare, ed è utilizzata es-
senzialmente per dare il via all’inquisizione.
7.4. Una voce fuori dal coro: la scettica razionalità di Giovanni Battista De Luca
A confronto delle ripetitive e scarsamente originali pagine di Farinacci, assai più incisi-
vi si mostrano i pochi ma densi capitoli dedicati ai giudizi criminali da Giovanni Batti-
4
sta De Luca. Il cardinale venosino non può essere certo annoverato tra gli specialisti
della materia; nondimeno, nel Dottor Volgare del 1673 (e precisamente nella seconda
parte del libro XV, intitolata Delli giudizi criminali, e della loro pratica nella Curia
Romana), abbandonando i sontuosi ma talora sconnessi itinerari barocchi seguiti da al-
tri giuristi della sua epoca, egli realizza una sintesi chiara e razionale, che individua e
delinea in maniera compiuta i nessi fondamentali della problematica penale seicentesca.
La prima questione – il «primo dubbio», nota De Luca – che ordinariamente si po-
ne nell’affrontare la materia penale, investe proprio il rapporto tra accusa e inquisizio-
ne: i giuristi sono soliti domandarsi, infatti, «se si possa, o no procedere per inquisizio-
4 Di famiglia borghese, Giovanni Battista De Luca (Venosa 1614 - Roma 1683) si laurea in utroque iure
nel 1635 a Napoli, ove inizia a esercitare la professione legale. Nel 1639 diviene vicario della sede
episcopale venosina. Nel 1644 si trasferisce a Roma, ove svolge le funzioni di uditore al servizio del
principe Ludovisi. A Roma esercita per lungo tempo e con straordinario successo la professione forense
come avvocato di curia. Dal 1669 pubblica il Theatrum Veritatis et Iustitiae, enciclopedica esposizione di
tutto il diritto, opera dotta e nel contempo frutto delle esperienze di pratico del foro. Al Theatrum segue,
nel 1673, Il Dottor Volgare, compendio dell’opera maggiore caratterizzato anche da finalità divulgative (e
per questo scritto in lingua italiana). Nel 1676, abbandonata l’avvocatura, abbraccia il sacerdozio e diviene
stretto collaboratore e ispiratore della politica e delle scelte di governo di Innocenzo XI dal quale, dopo la
nomina a giudice rotale, ottiene la porpora cardinalizia (1681).
63