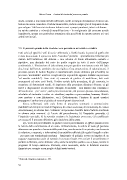Page 68 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 68
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
modo, accanto a una vasta attività editoriale, anche un’ampia circolazione di meno am-
biziose ma assai consultate Pratiche manoscritte, redatte sempre più di frequente in lin-
gua volgare. Tali lavori si risolvono talora in veri e propri prontuari, intesi a delineare –
tra spirito casistico e volontà di semplificazione – lo svolgimento del processo penale
inquisitorio, spesso con particolare attenzione alle specificità da questo assunte nei vari
ambiti territoriali.
7.2. Il processo penale delle Pratiche: una procedura ad assetto variabile
Fatti salvi gli specifici ‘stili di curia’ affermatisi a livello locale, la prassi di quello che
1
è stato denominato il «processo delle Pratiche» presenta – specialmente nella fase più
matura dell’evoluzione del sistema – uno schema di fondo abbastanza costante e
ripetitivo, non dissimile del resto da quello seguito in tutto il resto dell’Europa
continentale. L’illustrazione di tale schema non può peraltro non tenere conto del fatto
che, lungi dall’essere costituito da una rigida e fissa progressione di adempimenti, il
processo penale di Antico Regime è essenzialmente (come abbiamo già avvertito) un
processo ‘modulabile’ nell’iter e negli esiti (lo si potrebbe appunto definire un processo
‘ad assetto variabile’). Esso cioè: a) consente al giudice di modificare, dati certi
presupposti ed entro certi limiti, l’ordine seriale della procedura; b) gli consente, in
occasione di determinati snodi, di imprimere alla procedura direzioni diverse; c) gli
mette a disposizione un articolato ventaglio di modalità – non limitato alla condanna o
all’assoluzione – per ‘uscire’, anche provvisoriamente, dal processo (poena extraordinaria,
absolutio ab instantia o rebus sic stantibus; amplius cognoscendum, bannum, rilascio
cum cautione o cum fideiussione, ecc.). Evidentemente, l’insieme di questi caratteri
presuppone l’attribuzione al giudice di notevoli poteri discrezionali.
Senza soffermarci sulle varie forme di procedure sommarie o sommarissime
(adottabili ad esempio nei casi di flagranza, di crimen notorium, di contumacia, di crimen
atrocissimum), lo schema base ‘ordinario’ del processo descritto dalle Pratiche si articola
in almeno sette momenti: a) l’avvio del procedimento; b) l’inquisitio generalis; c)
l’inquisitio specialis; d) la repetitio testium e la legitimatio processus; e) la publicatio
processus; f) il processo difensivo; g) la decisione della causa.
a) L’avvio del procedimento. Il giudice avvia il procedimento ex officio quando riceva
la notizia della commissione di un reato. Ordinariamente, la notizia di reato gli perviene
attraverso una querela o denuncia della parte lesa, una denuncia di un privato, una denuncia
(o relazione, o rapporto, o informativa) di un pubblico ufficiale (di regola il bargello o altro
– per usare una terminologia moderna – funzionario di polizia), ovvero su impulso di un
istigator inquisitionis quale ad esempio l’avvocato fiscale. Per avviare il procedimento è
peraltro sufficiente, come abbiamo visto, anche la semplice publica vox et fama, mentre in
progresso di tempo assumono rilevanza, come accennato, anche le delazioni anonime
(imputate per esempio a non meglio definiti amici curiae).
1
Sbriccoli, Giustizia criminale, p. 199.
58