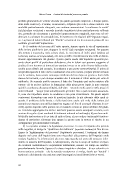Page 70 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 70
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
prestato giuramento de veritate dicenda (in quanto presunto colpevole, e dunque poten-
ziale testis contra se). L’esame, se necessario, è ripetuto più volte e viene condotto con
modalità particolarmente stringenti, con continue ammonizioni ‘a confessare la verità’
(ad fatendam veritatem) e secondo tecniche inquisitorie talora particolarmente raffinate
che, partendo da circostanze e particolari apparentemente marginali, sono tese ad evi-
denziare e a sfruttare le contraddizioni, le incertezze e le elusioni dell’imputato negati-
vo. La prassi di taluni tribunali più ‘liberali’ consente al reo di conoscere prima del suo
costituto gli esiti dell’inquisizione.
Se il costituto del reo non dà l’esito sperato, rimane aperta la via all’esperimento
della tortura giudiziaria ‘per strappare la verità’ (ad eruendam veritatem). Per passare
alla tortura è necessaria, onde evitare abusi, la sussistenza di indizi gravi (indicia ad
torturam; indicia ad torquendum), che sono peraltro rimessi ancora una volta al discre-
zionale apprezzamento del giudice. Questo quarto snodo dell’inquisitio specialis pre-
senta alcuni profili di particolare delicatezza, che in taluni casi possono suggerire al
giudice di non ricorrere ai tormenti per puntare invece su un esito diverso dalla condan-
na alla pena edittale (ad esempio, la condanna a una poena extraordinaria). Il primo di
tali profili riguarda il fatto che la confessione resa sotto tortura, proprio perché ottenuta
con la violenza, deve essere comunque ratificata dal reo dopo un giorno e fuori dalla
stanza dei tormenti, e può dunque accadere che il torturato si rifiuti anche più volte di
ratificarla. Un secondo profilo concerne il fatto che l’imputato può anche resistere alla
tortura: ciò da un lato inibisce la formazione della piena prova legale (e non consente
quindi la condanna alla pena edittale), dall’altro – secondo molti autori e nella prassi di
molti tribunali – ‘purga’ (cioè annulla) anche gli indizi fino a quel momento accumula-
ti, cosa che impedisce anche la condanna a una pena straordinaria. Da questi aspetti
controversi discendono una serie di questioni irrisolte, la più rilevante delle quali ri-
guarda il problema della durata e della ripetizione anche più volte della tortura (ad
esempio per ottenere una ratifica dapprima negata o al fine di eventuali chiamate in cor-
reità), spesso superato nella pratica con il consueto ricorso ai poteri arbitrari del giudi-
ce. Conviene aggiungere che anche i testimoni possono essere sottoposti a tortura, e ciò
avviene di regola: a) nei confronti di testimoni reticenti od ondivaghi; b) per dare credi-
bilità alla testimonianza di un teste di cattiva fama; c) per rendere inattaccabili testimo-
nianze di particolare rilevanza (ma spesso in questo caso la tortura si risolve in un
adempimento prevalentemente formale).
d) La repetitio testium e la legitimatio processus. In caso di imputato che persista
nella negativa, si svolge la ‘ripetizione dei testimoni’ (repetitio testium) al fine di rea-
lizzare la ‘legittimazione del processo’ (legitimatio processus). I testimoni che hanno
deposto nel corso dell’inquisizione sono riascoltati alla presenza dell’imputato onde
rendere ‘legittime’ le informazioni che sono state raccolte nel corso del processo infor-
mativo in assenza dell’imputato. L’adempimento, che ha lo scopo di mettere al riparo
da eventuali contestazioni le acquisizioni testimoniali, assume col tempo un carattere
prevalentemente formale. Spesso è lo stesso imputato a chiedere – di sua volontà o in
buona sostanza costretto – che la repetitio testium non si svolga, dando per ‘ripetuti’ i
testimoni e dichiarando che essi sono stati interrogati nei modi dovuti (rite et recte).
60