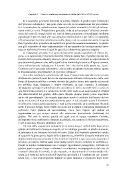Page 69 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 69
Capitolo 7 – Prassi e tradizione dottrinale in Italia dal XVI al XVIII secolo
b) L’inquisitio generalis. Ricevuta la notitia criminis, il giudice apre il fascicolo
del ‘processo informativo’, nel quale viene raccolta la documentazione del procedimen-
to e in particolare la verbalizzazione (opera del notaio criminale) di tutti gli adempi-
menti svolti, e avvia l’inquisizione generale, volta a) ad accertare l’effettiva commis-
sione del reato (il corpus delicti nei reati di fatto permanente è formalizzato mediante
sopraluoghi e perizie, negli altri casi attraverso testimonianze o per indizi e congetture),
e b) ad assumere le prime informazioni sullo stesso e sul suo eventuale autore. In questa
fase il giudice deve procedere ad acquisizioni generiche neminem nominando, in quanto
non gli è consentito di citare espressamente e di sua iniziativa (ad esempio mentre inter-
roga un testimone) il nome di qualche specifica e determinata persona sospetta.
c) L’inquisitio specialis. È il cuore del processo penale inquisitorio di Antico Re-
gime, e ne rappresenta il momento decisivo. Durante questa fase, il giudice (spesso sol-
lecitato dall’avvocatura fiscale) ricerca le prove idonee ad accertare la colpevolezza di
una determinata persona che, nella significativa terminologia tecnica all’epoca corrente,
viene ordinariamente indicata con il termine ‘reo’, che deriva dalla parola res, ‘cosa’.
Continua così il ‘processo informativo’, che peraltro da questo momento assume spesso
la denominazione, più pertinente, di ‘processo offensivo’.
Una volta accertata la commissione del reato, l’inquisizione speciale si può avviare
direttamente qualora il nome del reo sia espressamente indicato nella querela o nelle varie
forme di denuncia pubblica o privata ricevute dal giudice (come pure quando si proceda
per pubblica fama, flagranza o crimen notorium). In caso contrario, il passaggio
all’inquisitio specialis è subordinato alla sussistenza di indizi ancorché lievi a carico di
una determinata persona. La valutazione di tali indizi (indicia ad inquirendum) è affidata
alla discrezionalità del giudice, dalla quale dipende dunque questo primo importante
snodo del procedimento. Un secondo importante snodo è costituito dall’arresto del reo
anche in presenza di reati non particolarmente gravi. A tale riguardo spesso il discrimine
si colloca tra i reati a pena pecuniaria e i reati a pena corporale, ed è considerato rilevante
anche il pericolo di fuga. Resta il fatto che anche per la cattura è richiesta la sussistenza di
sufficienti indizi (indicia ad carcerandum), meno lievi rispetto agli indicia ad
inquirendum ma pur sempre rimessi alla valutazione discrezionale (arbitrium) del
giudice. Nei casi di minore gravità nei quali non si reputa necessario l’arresto,
all’imputato viene notificata la citazione in giudizio, che contiene il libellus inquisitionis,
e cioè la narrativa del fatto addebitato al reo.
Gli esiti delle acquisizioni probatorie (e in primo luogo i verbali delle deposizioni
giurate dei testimoni) rimangono segreti, né vi è obbligo generale, in questo momento,
di informare il reo detenuto del titolo del reato. Il fine dell’inquisitio generalis è quello
di acquisire la piena prova legale della colpevolezza, ottenibile di regola mediante una
duplice testimonianza concorde di due testimoni superiori a ogni eccezione (secondo il
principio di matrice biblica unus testis nullus testis) ovvero mediante la confessione.
Poiché la duplice testimonianza non è sempre agevolmente perseguibile, l’attività del
giudice punta in primo luogo a ottenere la confessione, accompagnata se del caso da
eventuali chiamate in correità. A tale riguardo, un adempimento di fondamentale rile-
vanza (e si tratta del terzo snodo dell’inquisitio specialis) è il ‘costituto del reo’ (consti-
tutum rei), e cioè l’interrogatorio formale al quale imputato è sottoposto dopo avere
59