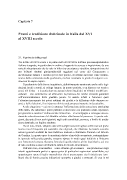Page 67 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 67
Capitolo 7
Prassi e tradizione dottrinale in Italia dal XVI
al XVIII secolo
7.1. Il primato della prassi
Tra la fine del XVI secolo e la prima metà del XVIII la dottrina processualpenalistica
italiana è segnata, in particolare in ordine al rapporto tra accusa e inquisizione, da una
sorta di sdoppiamento che la vede in bilico tra una stanca e ripetitiva riproposizione dei
pur brillanti risultati giurisprudenziali raggiunti nel corso del Cinquecento e
un’attenzione minuta e casistica per il dato pratico, di estremo interesse come testimo-
nianza della contrastata realtà giudiziaria, ma ben raramente in grado di volgersi a co-
struzioni di ampio respiro.
Il predominio delle forme inquisitorie, definitivamente sanzionate anche nelle legi-
slazioni locali e statali, si collega dunque, in questo periodo, a un distacco tra teoria e
prassi del diritto – e in particolare tra astratti schemi legalistici ed effettivi modelli pro-
cedurali – che contribuisce ad affievolire la presenza dei residui elementi garantisti
nell’amministrazione della giustizia penale. Si assiste infatti a fenomeni quali
l’ulteriore incremento dei poteri arbitrari dei giudici e la diffusione delle denunce se-
grete e delle delazioni, il cui rigoroso divieto cade progressivamente in desuetudine.
A tale situazione – cui non è estranea l’affermazione della concezione assolutista
dello Stato, che autorizza i poteri pubblici a intervenire con qualsiasi mezzo repressivo
per garantire e tutelare l’ordine sociale minacciato – si accompagna e consegue una so-
stanziale sclerotizzazione del dibattito relativo alla forma del processo. E questo ada-
giarsi, da parte di non pochi giuristi, sugli esiti consolidati, provoca, a livello di produ-
zione dottrinale, un duplice risultato.
Da un lato, infatti, vengono date alle stampe trattazioni spesso ambiziose sul piano
teorico ma di frequente più casistiche che originali, che illustrano la materia secondo
schemi generali ereditati da una tradizione risalente a Guillaume Durand e ad Alberto
da Gandino. In queste opere le questioni relative al modello accusatorio, sostanzialmen-
te ignorato nella pratica penale, vengono riprese in modo quasi tralatizio e finiscono
con l’assumere la stessa rilevanza formale di quelle relative al rito inquisitorio, cui non
di rado continua a essere attribuita la natura di rimedio straordinario.
Dall’altro lato, si intensifica – come abbiamo già accennato – una produzione dagli
intenti squisitamente pratici e spesso priva di particolari aspirazioni scientifiche, cui
appartengono opere di taglio manualistico che si preoccupano sia di sintetizzare i pro-
blemi che di fornire precise indicazioni operative a giudici e avvocati. Si crea in tal