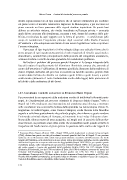Page 132 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 132
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
sfrutta argomentazioni sia di tipo umanitario che di matrice utilitaristica per confutare
sul piano teorico il modello relativistico impostato da Montesquieu, e per tracciare sul
piano concreto un fosco panorama delle vigenti strutture inquisitorie. Su queste basi
delinea un articolato sistema, che risulta incardinato sull’accusa privata – concepita
quale diritto connesso alla cittadinanza, concessa a tutti, dotata del carattere della pub-
blicità, e svincolata da ogni rapporto con la forma di governo – e condizionato (allo
scopo di neutralizzare l’argomento principe degli avversari della libertà d’accusa)
all’esistenza e alla scrupolosa osservanza di una severa legislazione volta a reprimere
l’accusa calunniosa.
Il processo di tipo inquisitorio è infine relegato (dopo una radicale riforma che lo
possa purgare di ogni aspetto persecutorio) al ruolo marginale di rimedio eccezionale e
straordinario, caratterizzato principalmente dalla presenza del «magistrato accusatore»,
versione riveduta e corretta in senso garantista del «vendicatore pubblico».
Nel trattare i problemi del processo penale Filangieri si fa dunque interprete della
fase più matura di quella corrente del riformismo illuminista europeo che, ponendo al
centro dell’attenzione l’edificazione di strutture giuridiche distaccate dalla tradizione di
Antico Regime, individua nel processo accusatorio un modello assoluto, proprio della
società ideale formata da cittadini cui spettano uguali diritti e uguali doveri, e quindi
condizionato (attraverso il ruolo fondamentale svolto dalla legge) dalla protezione di
tali diritti e dalla esaltazione di tali doveri.
11.7. Garantismo e modello accusatorio in Francesco Mario Pagano
Pur provenienti da un esponente della medesima cerchia di intellettuali riformisti parte-
4
nopei, le Considerazioni sul processo criminale di Francesco Mario Pagano, edite a
Napoli nel 1787, tradiscono una impostazione nel complesso assai diversa, e mostrano
nelle conclusioni una concretezza lontana dalla splendida ma talora utopica visione fi-
langieriana. Se infatti Pagano, come l’amico Filangieri, «colla fiaccola della filosofia»
segnala e sottolinea puntualmente «le profonde piaghe, che infermo e guasto rendono
l’universale criminal sistema di Europa», nel momento in cui volge il discorso al pro-
blema della riforma mostra di avere acquisito, nei lunghi anni di esercizio della profes-
sione forense, un profondo senso della realtà, che si manifesta anche quando si tratta di
trasportare dal livello teorico al piano pratico la questione della scelta e dei rapporti tra
4 Francesco Mario Pagano (Brienza 1748 - Napoli 1799), svolti studi privati e ottenuta la laurea legale
(1768), diviene ben presto uno dei più acclamati avvocati penalisti del foro di Napoli. Il suo pensiero
scaturisce da un Illuminismo dalle solide basi giusnaturalistiche incentrato sull’affermazione dei diritti
naturali dell’individuo, ed è caratterizzato da una serrata critica alle strutture politiche, sociali e giuridiche
dell’Antico Regime che si esprime nella serie dei Saggi politici (Napoli 1783-1792) e, per quanto riguarda
il problema penale, nelle Considerazioni sul processo criminale (Napoli 1787) e nei successivi Principi
del codice penale e Logica dei probabili (opera postuma, Milano 1803). Dal 1785 insegna Diritto
Criminale all’Università, ove dal 1770 era lettore di Etica. Nel 1789 è nominato avvocato dei poveri nel
Tribunale dell’Ammiragliato, presso il quale diviene giudice nel 1794. Nel 1796 è arrestato per
giacobinismo. Scarcerato nel 1798, dopo un breve periodo trascorso a Roma è protagonista, nel 1799, delle
vicende della Repubblica Partenopea, per la quale redige un rilevante e originale Progetto di Costituzione.
Caduta la Repubblica, muore sul patibolo della reazione borbonica.
122