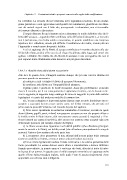Page 129 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 129
Capitolo 11 – Costruzioni ideali e proposte concrete alle soglie della codificazione
tra i cittadini. La seconda rileva l’esistenza, nelle legislazioni moderne, di una «indul-
genza perniciosa e non opportuna» nei riguardi dei calunniatori, giustificata dai difen-
sori dei metodi vigenti con il fatto che, perseguendo i calunniatori, non si troverebbe
più nessuno disposto a denunciare.
L’ampio discorso fin qui riassunto mira a dimostrare in modo definitivo che «la li-
bertà dell’accusa […] quando è ben combinata colla difficoltà di abusarne […] non solo
non è perniciosa», ma risulta «utile e necessaria», in quanto «stabilisce una reciproca
ispezione tra i cittadini», «rende più difficile l’occultazione dei reati», «rende più rara
l’impunità» e «rende meno frequenti i delitti».
A ciò si aggiunga che la libertà di accusa contribuisce in maniera decisiva alla sta-
bilità dello Stato, poiché offre una via di sfogo disciplinata dalla legge agli umori che
agitano i cittadini. Ne risulta che «la libertà di accusare è una prerogativa che non si
può separare dalla cittadinanza senza incorrere nei più gravi disordini».
11.4. La ricostituzione del sistema accusatorio
Alla luce di quanto detto, Filangieri sostiene dunque che per una corretta riforma del
processo penale sia necessario:
a) restituire a tutti i cittadini il diritto di accusare liberamente;
b) combinare tale diritto con l’impossibilità di abusarne.
Il primo punto è giudicato di facile attuazione. Assai più problematico si mostra
invece il secondo, per il cui conseguimento è opportuno ricorrere, con le dovute corre-
zioni e aggiunte, al seguente lungo catalogo di «mezzi» suggeriti in parte dalle antiche
legislazioni e in parte dal moderno modello di common law.
a) L’accusa calunniosa e la prevaricazione (intesa come accordo fraudolento tra ac-
cusatore e accusato) devono essere punite come nel diritto romano, che prevede nel
primo caso la pena dell’infamia e nel secondo la pena del taglione.
b) Deve essere ripristinata la normativa romanistica d’eccezione, secondo la quale
alcuni (donne, pupilli, servi, infami) non possono accusare se non «le proprie offese o
le insidie contro lo Stato intero», altri non possono essere accusati (i magistrati e i fun-
zionari assenti per causa di servizio), altri ancora non possono esser accusati «da certe
determinate persone» (ad esempio il padre dal figlio).
c) La libera accusa deve riguardare i soli delitti pubblici (che offendono principal-
mente la società e lo Stato); nei delitti privati (che offendono principalmente le singole
persone) l’azione deve spettare alla sola parte lesa.
d) L’accusatore deve promettere di non ritirarsi dall’accusa prima della sentenza
(come era stabilito ad Atene, a Roma e presso «alcune barbare nazioni»).
e) Deve essere rigidamente tutelata l’esatta osservanza e la valenza garantista delle
forme procedurali. Le accuse devono essere chiare e circostanziate e devono utilizzare
formule precostituite, in quanto «non vi è esattezza che basti, allorché si tratta di turba-
re la pace di un uomo». In questo caso al valido esempio romanistico si aggiunge anche
quello offerto dalla procedura inglese, nella quale l’atto di accusa (indictment) viene
approntato con estrema cura e diligenza.
119