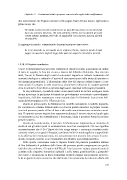Page 137 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 137
Capitolo 11 – Costruzioni ideali e proposte concrete alle soglie della codificazione
due osservazioni che Pagano inserisce nelle pagine finali del suo lavoro. Egli nota in
primo luogo che
Un rapido e pieno torrente si può torcere un poco dal suo corso, ma non gli si può
dare una contraria direzione. Chi nelle politiche riforme non ha davanti gli occhi
cotesta salutare massima, può belle ed ammirabili cose proporre; ma non già utili
ed eseguibili.
E aggiunge in seguito, commentando le proprie proposte innovative:
Se mi si domandi, se mai questa sia la migliore riforma, ripeto le parole di quel
saggio: son queste le migliori leggi, delle quali son capaci le circostanze presenti.
11.10. Riflessioni conclusive
Con le Considerazioni sul processo criminale si chiude in Italia, quantomeno in ordine
al tema in oggetto, la fase più vivace e intensa del dibattito illuminista. Due anni più
tardi, l’avvio in Francia degli eventi rivoluzionari segnerà un radicale mutamento del
contesto ideologico e culturale e l’aprirsi di una nuova epoca nella storia del pensiero e
dei sistemi giuspenalistici. L’illustrazione delle idee di Francesco Mario Pagano ci con-
sente quindi di svolgere, in sede conclusiva, alcune brevi riflessioni di carattere generale
circa le opinioni e le preferenze espresse dagli autori esaminati nelle pagine precedenti.
In via preliminare, è possibile notare come questi autori da un lato accolgano senza
alcuna incertezza la partizione dottrinale tra procedimento accusatorio e procedimento
inquisitorio, dall’altro mantengano come costante dato di riferimento la posizione deli-
neata da Montesquieu nel De l’Esprit des lois.
Quanto al primo punto, la distinzione tra modello accusatorio e modello inquisito-
rio costituisce lo schema formale entro cui ciascun giurista inserisce le proprie convin-
zioni sul processo penale al fine di dare a tali scelte una sistemazione razionale e accet-
tata. Il rapporto accusa-inquisizione rappresenta dunque il terreno sicuro sul quale agire
nel momento in cui, tra contraddizioni e incertezze, inizia a prendere forma il processo
penale moderno.
Quanto al secondo punto, il pensiero di Montesquieu rappresenta un momento di
svolta di cui gli autori presi in considerazione sono ben consapevoli. Ciò non significa
necessariamente che il De l’Esprit des lois venga sempre e comunque accettato acriti-
camente: taluni, e tra questi Filangieri, confutano infatti in modo esplicito e approfondi-
to le affermazioni montesquiviane, ma nel contempo non possono fare a meno di consi-
derarle elemento centrale e non trascurabile del dibattito processualpenalistico.
Detto questo, osserviamo come le risposte fornite dal pensiero penalistico italiano
di fine Settecento al problema della forma del processo penale compongano un quadro
tutt’altro che uniforme. Gli autori dell’Età dei Lumi possono vantare parecchi punti di
contatto nelle rispettive formazioni culturali e nelle letture giusfilosofiche e giuspoliti-
che svolte, e riconoscono in linea di massima al diritto romano una posizione autorevo-
le da un punto di vista sia storico che dottrinale. Ciò nonostante, le soluzioni offerte alla
127