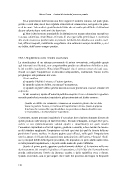Page 130 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 130
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
f) La prescrizione dell’accusa non deve seguire il modello romano, nel quale giun-
ge fino a venti anni, ma si deve ispirare al modello di common law, nel quale è in gene-
re di tre anni. Tale scelta è giustificata dal fatto che «è molto più difficile il difendersi
da una calunnia dopo venti anni che dopo tre».
g) Non è ulteriormente ammissibile la distinzione tra accusa calunniosa «semplice»
e accusa calunniosa «manifesta». Si tratta di una «parzialità perniciosa» e «contraria
alla civile sicurezza» perché mette in pericolo la libertà del cittadino con «indizi cavil-
losi, effimeri sospetti, metafisiche congetture». «La calunnia è sempre un delitto, e, se è
un delitto, debb’essere sempre punita».
11.5. L’inquisizione come rimedio eccezionale
La ricostituzione di un sistema processuale di natura accusatoria, realizzabile grazie
agli interventi ora illustrati, non comporterebbe peraltro un abbandono definitivo e tota-
le del modello inquisitorio. Nota infatti Filangieri che vi possono essere dei casi ecce-
zionali nei quali l’inquisizione si dimostra indispensabile, costituendo l’unico mezzo
per giungere alla punizione del reato.
Ciò si verifica:
a) «quando il delitto è sicuro, e l’autore ignoto»;
b) «quando esiste un delitto, ma manca l’accusatore»;
c) «quando la parte offesa querela ma non accusa» poiché non conosce il nome del
colpevole.
In tali occasioni, spetta all’autorità pubblica scoprire il reo e chiamarlo in giudizio
secondo particolari procedure inquisitorie già sperimentate nel diritto romano:
Quando un delitto era commesso e mancava un accusatore privato che ne chia-
masse in giudizio l’autore, si ricorreva all’inquisizione in Roma. Questo è appunto
il sistema che converrebbe oggi di adottare. La procedura ordinaria dovrebbe esse-
re l’accusatoria, e la straordinaria l’inquisitoria.
Certamente, questo processo inquisitorio d’eccezione deve risultare alquanto diverso da
quello praticato nell’Europa di fine Settecento. Secondo Filangieri, la legge deve prov-
vedere ai casi (ottimisticamente valutati «pochi e straordinari») nei quali manchi
l’accusatore ispirandosi a criteri di ragione, giustizia e umanità, e deve tutelare la sicurez-
za del cittadino spogliando l’inquisizione «di tutti quei vizi dei quali la ferocia della su-
perstizione l’aveva vestita». In alcune pagine assai efficaci, nelle quali l’impostazione
retorica appare vivificata dalla appassionata partecipazione dell’autore, Filangieri ribadi-
sce i principali difetti della vigente procedura, che dipendono in parte «dalla natura istes-
sa della presente inquisizione», e in parte «dalle mani alle quali è affidata».
Quanto al primo punto, appaiono particolarmente deleteri a) la riunione nella me-
desima persona dei compiti di giudice e di accusatore, e b) il fatto che il procedimento
prenda ordinariamente l’avvio da denunce occulte o dalla «pubblica voce o fama».
Quanto al secondo, non si può negare che l’esito del processo sia troppo di frequente
120