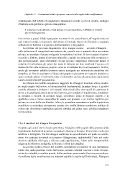Page 131 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 131
Capitolo 11 – Costruzioni ideali e proposte concrete alle soglie della codificazione
condizionato dall’arbitrio di magistrati e funzionari corrotti e privi di credito, «indegni
d’influire sulla pubblica e privata tranquillità»:
Il ministero il più delicato, il più geloso e il più importante, è affidato ai ministri
più vili della giustizia.
Per ovviare a questi difetti e per poter ricorrere in via straordinaria all’inquisizione nei
casi sopra ricordati, è necessario ripristinare «il metodo istesso dei Romani» e separare
nettamente le funzioni e le persone dell’accusatore e del giudice.
La riforma del processo inquisitorio deve dunque ruotare – secondo Filangieri –
sulla istituzione di «magistrati accusatori» che, quando non si presenti alcun accusatore
privato, ne prendano il posto svolgendo le medesime funzioni. Si deve trattare di perso-
ne probe e distinte, dotate di un buon stipendio e quindi non propense alla corruzione o
alla prevaricazione. Esse nell’ambito di una precisa competenza territoriale hanno il
compito di individuare gli autori dei reati, di istituire nei loro confronti l’accusa e di
sostenerla fino alla sentenza, proprio come se si trattasse di privati accusatori. Inoltre,
anche gli accusatori pubblici possono essere perseguiti per calunnia sia manifesta che
semplice, al fine di suscitare la fiducia del popolo e per porre un ostacolo decisivo a
ogni eventuale abuso. In tal modo, tutto si ridurrebbe «a dare alla procedura inquisitoria
tutta la semplicità dell’accusatoria».
La riforma del modulo inquisitorio suggerita da Filangieri dovrebbe allora condur-
re, negli auspici dell’autore, ad alcuni risultati fondamentali. In primo luogo, il giudice
sarebbe chiamato a svolgere i soli compiti istituzionali (che sono quelli di esaminare le
prove e di giudicare), senza dover più ricorrere, per condurre l’inquisizione, a subalter-
ni «venali» e corrotti. In secondo luogo, verrebbero meno le denunce segrete, e la
«pubblica voce e fama» cesserebbe di essere «un pretesto o un motivo legittimo per
privare un uomo della sua libertà». Infine, la procedura accusatoria e quella inquisitoria
verrebbero a coincidere pienamente eccetto che «nella diversa condizione politica di
coloro che dovrebbero instituirla» (privati cittadini nel primo caso, pubblici magistrati
nel secondo).
11.6. I caratteri del disegno filangeriano
Rispetto agli autori che lo hanno preceduto, Filangieri nelle pagine della Scienza della
Legislazione dedicate al processo accusatorio traccia un disegno riformistico molto più
analitico e dettagliato. Da tale disegno scaturisce un procedimento nel quale si manife-
stano due principi ricorrenti nel pensiero filangieriano, individuabili l’uno nel ruolo
decisivo attribuito alla legge e alla sua esatta applicazione, l’altro nella insopprimibile
esigenza di difendere la dignità, la libertà e i diritti del cittadino.
La precisa scelta a favore del modello accusatorio si inserisce in una costruzione
ideale che, nella passione civile dell’autore, assume contorni concreti e reali. Ricono-
sciuta la centralità, in ambito penale, della questione processuale (decisiva per risolvere
il problema della conciliazione tra interessi pubblici e tutela dell’individuo), Filangieri
121