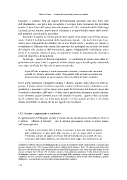Page 126 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 126
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
terpretare e ordinare tutti gli aspetti dell’esperienza giuridica alla luce delle idee
dell’Illuminismo, una parte non secondaria è occupata dalla trattazione del problema
penale. Il terzo libro dell’opera, dato alle stampe nel 1783, si intitola infatti Delle leggi
criminali; al suo interno, ampio spazio è dedicato a un approfondito esame delle princi-
pali questioni concernenti la procedura.
Secondo Filangieri, la riforma penale deve essere innanzitutto una riforma proces-
suale. Poiché il problema centrale della legislazione penale – che ha la funzione di ga-
rantire sia la tranquillità dei cittadini che la loro libertà civile – consiste nel riuscire a
«combinare» l’efficacia delle norme («lo spavento dei malvagi») con la tutela dei diritti
del singolo («la sicurezza dell’innocente»), appare indispensabile individuare, ancor
prima di un corretto sistema di pene, un opportuno metodo di procedura che risponda a
criteri di chiarezza e di semplicità.
In Europa – osserva il filosofo napoletano – le condizioni di questo ramo della le-
gislazione sono assai tristi. Le parziali riforme attuate qua e là nella parte sostanziale
sono state vanificate dal fatto che la parte processuale,
la più difficile a ripararsi e la più interessante a trattarsi, è rimasta nella sua antica
oscurità. Lo strepito universale contro l’irregolarità della presente procedura non
ha ancora fatto nascere un nuovo metodo, che si dovrebbe all’antico sostituire.
Poste queste premesse, Filangieri sviluppa e illustra, guidato dalla «fiaccola della ra-
gione», il proprio piano di riforma operando continui richiami storici, dottrinali e com-
paratistici, e ponendo in primo piano come punti di riferimento del discorso da un lato
il modello romanistico, dall’altro – il dato merita particolare attenzione poiché introdu-
ce un elemento sostanzialmente nuovo nel dibattito in esame – quello offerto dal siste-
ma di common law, che «se nella parte penale è vizioso quanto gli altri, è nel tempo
istesso ammirabile in quella che ha per oggetto la procedura».
11.3. Accusa e inquisizione a confronto
Il ragionamento di Filangieri prende le mosse da una decisa presa di posizione. Non vi
è dubbio – afferma il filosofo – che il sistema processuale ideale si debba basare
sull’accusa privata:
La libertà o, per meglio dire, il diritto di accusare, è stata una delle prerogative
della cittadinanza in gran parte delle nazioni, e per un lungo tratto di secoli.
L’interesse comune ed eguale che hanno tutti gl’individui di una società alla con-
servazione dell’ordine pubblico, all’osservanza delle leggi, alla diminuzione dei
amministra il Monte Nuovo dei Maritaggi (che si occupa dei problemi dotali, matrimoniali e monastici dei
giovani nobili), e nel 1787 diviene membro del Consiglio delle Finanze. Dal 1776 dedica gran parte della
sua breve vita alla stesura della monumentale Scienza della legislazione, che viene data alle stampe in otto
volumi a Napoli dal 1780 al 1791 (l’ultimo volume viene pubblicato postumo). Pietra miliare del maturo
Illuminismo europeo e punto di svolta per gli sviluppi delle moderne scienze politico-sociali, l’opera
costituisce un vero e proprio progetto costituzionale di rifondazione della società civile destinato a grande
diffusione e a un duraturo successo nella cultura giuspolitica europea.
116