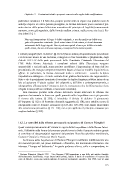Page 125 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 125
Capitolo 11 – Costruzioni ideali e proposte concrete alle soglie della codificazione
particolare menzione è il fatto che, proprio perché entra in vigore con qualche mese di
anticipo rispetto al codice penale giuseppino, la Norma Interinale possa vantare il pri-
mato storico della prima definizione normativa del principio di legalità (comunemente
espresso, come già segnalato, dalla formula nullum crimen, nulla poena sine lege). Re-
cita infatti il § 1:
Non ogni trasgressione di legge è delitto criminale, o per dir meglio un delitto sog-
getto alla procedura criminale. Quali azioni siano di tale natura, si dovrà desumere
unicamente dalle leggi vigenti. Non si potranno quindi ritenere per delitto criminale
quelle azioni, che non si trovano espresse, e comprese fra le sanzioni penali.
I restanti paragrafi (Artt. II-XXXV, §§ 10-363) hanno natura più spiccatamente procedurale
e si risolvono invece in una revisione, sviluppata su basi razionaliste e pragmatiche, degli
Articoli XIX-LIV della parte processuale della Constitutio Criminalis Theresiana del
1768. Nella Norma Interinale i complessi schemi della Theresiana vengono
ammorbiditi e resi più agili, senza peraltro modificare l’impostazione di base dell’iter
procedurale, che resta pur sempre strettamente legato al classico modello inquisitorio ex
officio. In particolare, la Norma Interinale tende a enfatizzare – secondo la tipica
impostazione asburgica – il ruolo centrale di un giudice-funzionario che rappresenta lo
Stato e che è specialmente incaricato di esercitare la duplice funzione pubblica intesa da un
lato ad assicurare il ‘giusto castigo’ del colpevole e, dall’altro e contemporaneamente, a
salvaguardare efficacemente l’innocenza (con la conseguenza che la difesa tecnica viene
relegata in una posizione residuale e meramente eventuale).
Non mancano peraltro nella Norma Interinale alcuni interventi di riforma che
appaiono decisamente in linea con quelli presenti nella Leopoldina: non è più previsto
il ricorso alla tortura (§ 238); è introdotto il divieto di deferire il giuramento
all’imputato (§ 162) e di formulare domande suggestive (§ 158); sono stabilite norme di
salvaguardia contro le denunce calunniose (§ 125-126, 129-130); sono fissati taluni limiti
alla carcerazione preventiva (§ 131-136); non è più applicato il principio contumax pro
confesso habetur (§ 309).
11.2. La centralità della riforma processuale nel pensiero di Gaetano Filangieri
Quasi contemporaneamente all’entrata in vigore della Leopoldina e della Norma Interi-
nale, il dibattito sulla forma del processo penale tocca in Italia il proprio culmine grazie
al contributo di due prestigiosi esponenti del pensiero filosofico-giuridico meridionale,
Gaetano Filangieri e Francesco Mario Pagano.
La Scienza della Legislazione di Gaetano Filangieri costituisce indubbiamente uno
dei momenti più alti, sul piano dottrinale e filosofico, del movimento riformatore che
3
interessa l’Europa nel Settecento. In questo poderoso sforzo, volto a comprendere, in-
3 Gaetano Filangieri (Napoli 1753 - Vico Equense 1788) appartiene a una delle più antiche famiglie
dell’aristocrazia meridionale. Dopo intensi studi privati, ottiene il titolo di Gentiluomo di Camera alla
corte di Napoli e avvia una carriera militare di carattere prettamente onorifico. Dal 1780 e per tre anni
115