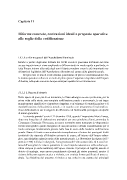Page 121 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 121
Capitolo 11
Riforme concrete, costruzioni ideali e proposte operative
alle soglie della codificazione
11.1. Le riforme penali dell’Assolutismo illuminato
Mentre a partire dagli anni Settanta del XVIII secolo il panorama dottrinale sul tema
accusa-inquisizione si viene ampliando e differenziando in modo rapido e profondo, in
tutta Europa intorno alla metà degli anni Ottanta prendono corpo le più importanti ma-
nifestazioni legislative dell’Assolutismo riformista nel campo della giustizia penale.
Nel processo se non di totale riforma quantomeno di precoce modernizzazione del-
la materia penale si colloca in un ruolo di primo piano l’esperienza legislativa dell’Impero
d’Austria, sulla quale conviene dunque anticipare qualche breve informazione.
11.1.1. L’Impero d’Austria
Nello spazio di poco più di un trentennio, lo Stato asburgico avvia e perfeziona, per la
prima volta nella storia, una compiuta codificazione penale e processuale, le cui tappe
maggiormente significative rispondono dapprima a un’esigenza di centralizzazione e di
standardizzazione della giustizia penale, e in seguito a un programma di razionalizza-
zione della stessa in cui le esigenze di efficienza e di funzionalità prevalgono su quelle
di natura garantista.
La vicenda prende l’avvio il 31 dicembre 1768, quando l’imperatrice Maria Teresa,
dopo una lunga fase di elaborazione protrattasi per una quindicina d’anni, promulga la
Constitutio Criminalis Theresiana, un corpo normativo tanto trascurato (e vituperato) a
livello storiografico quanto bisognoso di una più matura e attenta considerazione per il
ruolo comunque fondamentale giocato nella fase di avvio della moderna codificazione
penale. Siamo di fronte a una sostanziale ricompilazione e fusione dei previgenti diritti
territoriali che risponde all’obiettivo primario di creare, all’interno dell’Impero asbur-
gico, una disciplina unitaria anche della materia penale. La Theresiana (in vigore dal 1°
gennaio 1770) è divisa in due parti, l’una processuale l’altra sostanziale, ed è assai lon-
tana dall’accogliere le istanze garantiste in via di rapida maturazione nella cultura giu-
ridica europea (e anche austriaca) dell’epoca. Assente il principio di legalità, assente il
divieto di analogia, sono ancora parzialmente rilevanti gli status personali, mentre il
sistema delle pene appare arcaico e violento, con svariate forme qualificate di pena ca-
pitale. La disciplina del processo si risolve a sua volta in una summa dei principali