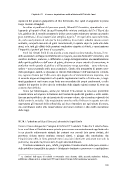Page 113 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 113
Capitolo 10 – Accusa e inquisizione nella dottrina dell’Età dei Lumi
esponenti del pensiero giuspolitico di fine Settecento, tra i quali va segnalato in primo
luogo Gaetano Filangieri.
In ordine ai problemi del processo penale, Schmid D’Avenstein, riprendendo e svi-
luppando gli spunti offerti da quell’inesauribile miniera costituita dal De l’Esprit des
lois, giudica che il metodo accusatorio debba essere usato solamente «presso un popolo
11
poco numeroso, i di cui costumi sian semplici, e puri». «In ogni altro caso» tale meto-
do, sorto «col pretesto di zelo per lo ben pubblico, di cui tutti i cittadini devono essere
animati», comporta una serie di gravi inconvenienti, in quanto «apre la porta alle dela-
zioni, ed a tutti gli effetti delle passioni vendicative rispetto ai deboli, e quasi assicura
l’impunità ai potenti pel timor d’accusargli».
Fuori dai ristretti limiti di una piccola e sana organizzazione statuale, dunque, il mo-
dello accusatorio sviluppa inevitabilmente nel popolo, secondo Schmid D’Avenstein, «un
carattere traditore, ombroso, o diffidente» e, lungi dal rappresentare una manifestazione
dello spirito pubblico e dell’amor di patria, diviene un sicuro veicolo di corruzione, in
particolar modo quando al giudice e all’accusatore venga accordata – come soleva ac-
cadere – una percentuale sulle pene pecuniarie. Grazie alla prospettiva di questo «sor-
dido guadagno», infatti, si spezzano «i vincoli della fidanza e dell’amicizia fra i cittadi-
ni», ognuno diviene per l’altro «una spia pagata da un’amministrazione inquieta», non
si concede tregua ai trasgressori «di qualche regolamento inutile e di minuzie», i magi-
strati guardano ai reati come a una fonte non secondaria dei propri emolumenti, e nello
«spirito del popolo» le idee circa la rettitudine delle singole azioni cessano di avere un
contorno ben definito.
Come per Montesquieu, anche per Schmid D’Avenstein la soluzione preferibile
consiste allora nel separare la funzione dell’accusa da quella del giudizio e nello «stabi-
lire una parte pubblica, che sia incaricata di accusare coloro, che si rendon colpevoli dei
delitti contro la società». Tale magistratura «non ha nulla d’odioso» in quanto non solo
rappresenta gli interessi della collettività, cui deve rispondere per ogni abuso di potere,
ma contribuisce anche alla conservazione dei buoni costumi e alla esatta esecuzione
delle leggi.
10.10. L’adesione critica di Renazzi al modello inquisitorio
Renazzi ricava dunque dai Principes di Schmid D’Avenstein l’idea che il sistema basa-
to su una libera e illimitata accusa privata possa essere convenientemente applicato solo
in un piccolo ordinamento statuale dai costumi non corrotti («in parva civitate, ubi
praeterea civium mores nondum corrupti sint»), e giunge alla conclusione che
l’inquisizione offra in linea generale mezzi assai più idonei per assicurare non solo la
punizione, ma anche la prevenzione di ogni attività delittuosa.
Il metodo accusatorio puro, infatti, pregiudica il mantenimento della pace sociale e
della pubblica tranquillità in quanto è fatalmente destinato a provocare e a moltiplicare
11 Le citazioni dall’opera di Schmid D’Avenstein sono desunte dalla seconda traduzione italiana,
pubblicata a Massa in due volumi nel 1787 con il titolo Principj della legislazione universale.
103