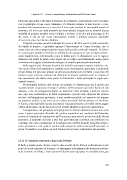Page 117 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 117
Capitolo 10 – Accusa e inquisizione nella dottrina dell’Età dei Lumi
tribuendo agli indizi e alla fama la funzione di accusatore, confondendo così il «mezzo»
con il «principio di una causa criminale». De Simoni confessa di non riuscire a com-
prendere tale impostazione: se è vero che il Fisco può «vestirsi di una qualità morale di
persona», ciò non è per nulla possibile per «enti astratti, incapaci per se stessi di alcuna
modalità di persona morale» come l’indizio e la fama. E ciò che più preoccupa, in fin
dei conti, è che da tali «cose fallacissime, incerte o dubbie» possono dipendere
«l’onore, la vita e la roba dei cittadini».
Il vigente processo penale ha dunque ben poco a che fare con il corretto «esercizio
del diritto di punire», e giustifica appieno l’osservazione di Cesare Beccaria, che vi
aveva visto una vera e propria guerra mossa dalla società contro gli imputati. De Simo-
ni si preoccupa peraltro di limitare la validità di tale paragone al solo «sistema del pro-
cesso inquisitorio», sottolineando come si debba porre in discussione non la ragione
intrinseca del diritto di punire, ma l’abuso che si verifica quotidianamente nella pratica
criminale e che appare strettamente collegato al modello processuale dominante.
Nelle pagine testé illustrate la scelta del modello accusatorio appare implicita e de-
riva da un rifiuto dell’inquisizione costruito su un’impostazione garantista e umanitaria
del problema del processo penale. In altri passi presenti nel Del furto e sua pena De
Simoni è però assai più esplicito nel dichiarare la propria preferenza per un sistema di
tipo accusatorio che abbia come punto di riferimento e fonte principale le regole pro-
cessuali romane.
Nel paragrafo dedicato alla cattura, ad esempio, De Simoni nota che il giudice nel
vigente metodo inquisitorio è dotato di arbitrio nell’esaminare «gli indizi bastevoli alla
cattura», e che di conseguenza spesso un innocente viene arrestato e posto in carcere
solo «per una combinazione di fatali circostanze». Questo male «dipende dal sistema
adottato dell’inquisitorio processo», e non sarebbe possibile col «metodo del romano
accusatorio» poiché, se gli indizi per la cattura presentati dall’accusatore «si risolvono
in fumo», costui subirebbe la pena prevista per l’accusa temeraria e dovrebbe inoltre pagare
i danni all’accusato, «il che non avviene nel metodo adottato nel processo inquisitorio».
Analogamente, nel paragrafo sulla prigionia De Simoni denuncia ancora una volta
come i poteri pressoché illimitati del giudice-inquisitore nei confronti dell’imputato
portino di frequente all’oppressione dell’innocenza attraverso la privazione della libertà
personale, il sequestro dei beni e altri duri provvedimenti restrittivi, ma sottolinea nel
contempo che «una conseguenza di tal natura» non sarebbe neanche pensabile nel pro-
cesso accusatorio, «nel quale il giudice nulla eseguisce sulla persona dell’accusato, se
prima l’accusatore non abbia con sodi fondamenti provata e sostenuta la sua accusa».
10.12. Il complesso panorama degli anni Settanta
È facile a questo punto rilevare come le idee accolte da De Simoni si allontanino in più
punti da quelle espresse da Renazzi e si oppongano radicalmente alle posizioni sostenu-
te da Cremani. In effetti, i lavori giovanili dei tre autori qui presi in considerazione, pur
107