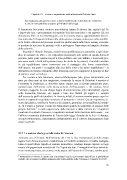Page 109 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 109
Capitolo 10 – Accusa e inquisizione nella dottrina dell’Età dei Lumi
tura medesima del governo, dove è ottimo stabilimento il destinare de’ commissa-
ri, che in nome pubblico accusino gl’infrattori delle leggi.
Il frammento beccariano contiene una sintetica lettura di almeno due capitoli del De
l’Esprit des lois, e precisamente del capitolo VIII del sesto libro e del capitolo XX del
dodicesimo libro. In essi Montesquieu, con la consueta tecnica apparentemente descrit-
tiva intessuta di frequenti richiami alla storia greca e romana, nota come nella repubbli-
ca la forma ordinaria del processo penale sia quella basata sulla libera accusa, circonda-
ta peraltro da una serie di garanzie volte a proteggere l’innocenza del singolo cittadino
dalle calunnie.
Secondo il filosofo francese, nella Roma repubblicana era consentito a ogni citta-
dino di accusare un altro, e ciò rispondeva pienamente allo spirito di questa forma di
governo, nella quale ognuno ha per il bene pubblico uno zelo infinito e tiene nelle pro-
prie mani «tutti i diritti della patria» («tous les droits de la patrie»). Il modello adottato
in età repubblicana venne conservato con il passaggio alle forme monarchiche
dell’impero, ma portò – in seguito alla crisi delle virtù e dei valori repubblicani – al
diffondersi del funesto fenomeno delle delazioni, nate per compiacere il principe al fine
di ottenere onori e privilegi.
Per ovviare a tale fenomeno, osserva Montesquieu (che, giova rammentarlo, era
stato per dieci anni un alto magistrato, rivestendo la carica di Président à mortier al
Parlement di Bordeaux), si dovrebbe allora seguire non il sistema inquisitorio puro,
caratterizzato dall’unione nella stessa persona dell’accusatore e del giudice, bensì
l’esempio suggerito da una «legge degna di ammirazione» («loi admirable») vigente
nella monarchia francese, che separa e tiene ben distinti gli organi e i compiti
dell’accusa da quelli del giudizio. In Francia, infatti, il sovrano nomina presso ogni tri-
bunale un apposito magistrato incaricato di perseguire i crimini. Questo magistrato, di-
verso dal giudice, vanifica la funzione dei delatori, garantisce la tranquillità dei cittadi-
ni, ed è tenuto a palesare i nomi dei denuncianti quando sia sospettato di abusare delle
9
proprie funzioni. La netta separazione delle funzioni e delle carriere tra i magistrati
incaricati di condurre l’accusa e i magistrati incaricati della decisione delle cause – con
l’ufficio meramente dichiarativo di ‘bocca della legge’ (bouche de la loi) – è dunque,
secondo Montesquieu, il presupposto indispensabile per il corretto funzionamento della
giustizia penale.
10.7. La matrice ideologica delle scelte di Cremani
Torniamo ora a Cremani. Nell’Orazione del 1775 le idee fondamentali a) dello stretto
legame tra la forma di governo repubblicana e il modello accusatorio e b) della inadegua-
tezza di quest’ultimo rispetto al sistema monarchico, risultano dunque ispirate in larga
misura alle pagine testé ricordate del De l’Esprit des lois. L’innegabile influsso del relati-
vismo montesquiviano, che permea molte pagine dell’opuscolo di Cremani, sembra peral-
9 Montesquieu si riferisce in questo caso ai procuratori regi (e ai procuratori signorili per le giurisdizioni
feudali), che esercitano il pubblico ministero nelle forme stabilite dalla Ordonnance Criminelle del 1670.
99