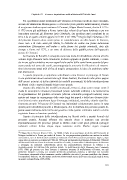Page 111 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 111
Capitolo 10 – Accusa e inquisizione nella dottrina dell’Età dei Lumi
Tra i pochissimi autori menzionati nell’Orazione di Cremani merita di essere ricordato,
accanto all’«immortale Montesquieu» e a Beccaria (citato peraltro indirettamente), il nome
di un giovane studioso quasi coetaneo di Cremani, Filippo Maria Renazzi, che tra il 1773 e
il 1775 aveva già pubblicato a Roma i primi due volumi di un’opera destinata a una non
immeritata notorietà, gli Elementa Iuris Criminalis, che sarebbero stati completati da un
10
terzo e da un quarto volume apparsi nel 1781 e nel 1786. Ma più degli Elementa ai fini
del presente discorso deve essere preso in considerazione un altro lavoro di Renazzi,
meno noto e di mole assai più ridotta, la Diatriba de ordine seu forma iudiciorum
criminalium (Discussione sull’ordine e sulla forma dei giudizi criminali), data alle
stampe a Roma nel 1777, a un anno di distanza dalla pubblicazione dell’opuscolo
pavese di Cremani.
La Diatriba di Renazzi è concepita come una sorta di introduzione storica al terzo
volume degli Elementa Iuris Criminalis, dedicato appunto ai giudizi criminali, e consi-
ste in una agile e sintetica ma non superficiale analisi delle varie forme assunte dal pro-
cesso penale nel corso dei secoli, accompagnata da una serie di riflessioni e di osserva-
zioni che tornano assai utili al fine di meglio comprendere le idee e la posizione cultu-
rale dell’autore.
A questo proposito, è opportuno sottolineare come Renazzi si proponga di fissare
in via preliminare alcuni concetti che egli ritiene basilari, illustrando nelle prime pagine
dell’opera i principi: a) della relatività dei modelli processuali; b) della interdipendenza
tra libertà civile e aspetti formali del processo penale.
Quanto alla relatività dei modelli processuali, Renazzi, dopo avere notato come il
modo di concepire le strutture processuali («ratio iudicialis ordinis») e la stessa forma
di organizzazione del giudizio criminale («forma criminalis peragendi iudicii») siano
mutate nel tempo in conseguenza delle varie leggi dei popoli e delle loro diverse istitu-
zioni («iuxta varias populorum leges diversaque instituta»), conclude, citando significa-
tivamente proprio l’Orazione di Cremani ma ispirandosi evidentemente (come in tutta
questa parte introduttiva) anche a Montesquieu, che la struttura del processo penale di-
pende essenzialmente dalla forma del governo civile («ordo criminalis iudicii a civilis
regiminis forma vel maxime pendet»).
Quanto al principio della interdipendenza tra libertà civile e aspetti formali del
processo penale, Renazzi afferma che quando viene a mancare una precisa
regolamentazione del processo penale la libertà civile corre gravi pericoli («absque
iudiciarii ordinis forma aliqua atque sanctione civilis libertas vigere nequeat
10 Filippo Maria Renazzi (Roma 1745 - ivi 1808) è figlio di un professore di diritto dell’Università di
Bologna trasferitosi a Roma per motivi di lavoro. La sua preparazione giuridica non matura in ambito
universitario, ma è il frutto di studi condotti privatamente. Dal 1763 esercita la professione legale e, dopo
avere vinto un concorso a cattedra nel 1768, dal 1769 e per un trentennio è professore di Istituzioni Criminali
all’Università di Roma. Ricco di interessi scientifici ed eruditi, è ammiratore di Montesquieu e di Beccaria
e propugna da posizioni culturalmente aperte ma sostanzialmente moderate la riforma e la
razionalizzazione del sistema della giustizia penale. La pubblicazione degli Elementa Iuris Criminalis
(1773-1786) gli procura una fama europea e numerose proposte di trasferimento all’estero, ma egli
preferisce rimanere a Roma, ove accanto all’attività accademica continua a esercitare con successo
l’avvocatura, ricoprendo altresì numerose cariche pubbliche sia sotto il governo pontificio che durante
l’occupazione francese. Dà alle stampe anche una monumentale Storia dell’Università degli Studi di Roma
in quattro volumi (Roma, 1803-1806).
101