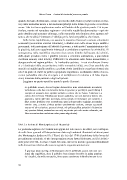Page 108 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 108
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
quando derivano direttamente, «come un ruscello dalla fonte» («veluti rivulum ex fon-
te») dalla medesima natura e dai medesimi principi della forma di governo cui si riferi-
scono. Tale tesi trova applicazione anche nell’ambito della giustizia penale. Più in par-
ticolare, mentre nel «populare regimen» – cioè nella repubblica democratica – ogni sin-
golo cittadino può accusare chiunque, nella monarchia tale funzione deve spettare sol-
tanto a che ne abbia l’interesse o l’obbligo per la funzione pubblica che riveste.
Nelle forme repubblicane, ove assume la massima rilevanza la comune volontà dei
consociati («communis omnium voluntas»), i cittadini sono nello stesso tempo sudditi e
governanti: tutti partecipano all’attività di governo, a tutti spetta l’amministrazione del-
la giustizia, tutti sono ugualmente interessati a combattere e reprimere la criminalità. Di
conseguenza, nella repubblica «nessuno deve essere distolto dall’accusa dei crimini,
dalla quale prendono avvio i giudizi» («nemo a criminum adcusatione, a qua iudicia
exordium sumunt, reiici debet»). Differente è la situazione nelle forme monarchiche, e
dunque anche nel regime politico – la Lombardia austriaca – in cui si collocano Crema-
ni e i destinatari della sua prolusione. Nelle monarchie infatti, ove è ben possibile che
manchi nei sudditi quella «sublime e perfetta virtù» («sublimis et perfecta virtus») che
sola è in grado di tenere in piedi la «popularis respublica», un illimitato diritto di accu-
sa non porterebbe altro che al sorgere e al moltiplicarsi di calunnie e di false imputa-
zioni, innescate dalle passioni e dagli odi privati.
Leggiamo su questo specifico punto le parole Cremani:
Le pubbliche accuse, che nel regime democratico sono assolutamente necessarie,
nulla hanno a che fare con la nostra forma di governo; e poiché [in quest’ultima] il
compito di accusare deve spettare soltanto a coloro che ne hanno l’interesse o a
coloro che ne hanno l’obbligo per dovere pubblico, noi non dovremo temere che
qualcuno, spinto dall’odio personale, possa tentare di molestarci con calunnie o
false accuse (Publicae vero accusationes, quae in democratico regimine necessariae
omnino sunt, a nostra civitate penitus quodammodo exulant; cumque accusandi
munus vel ad eos tantum, quorum interest, vel quibus publica potestate id iniunctum
est, spectare debeat, metuendum non erit, ne privato quis odio motus calumniis, aut
falsis accusationibus molestiam nobis parere adgrediatur).
10.6. La lezione di Montesquieu (e di Beccaria)
La posizione espressa da Cremani non appare del tutto nuova. In effetti, essa corrispon-
de nelle linee generali all’interpretazione data negli ambienti illuministi ad alcuni passi
che Montesquieu dedica nel De l’Esprit des lois del 1748 al problema della forma del
procedimento criminale. A tale interpretazione aveva fatto riferimento, nel Dei delitti e
delle pene del 1764, lo stesso Cesare Beccaria, che aveva inserito quasi incidentalmente
nella discussione relativa alle accuse segrete la seguente annotazione:
È già stato detto dal Sig. di Montesquieu che le pubbliche accuse sono più con-
formi alla repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione
de’ cittadini, che nella monarchia, dove questo sentimento è debolissimo per la na-
98