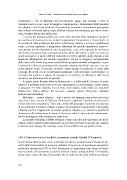Page 112 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 112
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
incolumis»), e che la disciplina del procedimento appare più accurata e ricca di
formalità laddove sono tenuti in maggiore considerazione i fondamentali diritti (naturali)
dei cittadini, e cioè la vita, la libertà e la reputazione («constate o accuratiorem prescriptum
esse ordinem criminalis iudicii, eoque pluribus refertum solemnitatibus, quo maior civium
vitae, libertatis, famae ratio habita est»).
La storia del processo penale così come viene descritta nella Diatriba si risolve in
una continua alternanza tra i due sistemi fondamentali, l’accusatorio e l’inquisitorio. A
un periodo di netta prevalenza del primo nella Grecia classica e in Roma repubblicana
segue, in Roma imperiale, il progressivo affermarsi del modello inquisitorio senza ac-
cusa privata («ordo inquisitorius sine accusatore»), a sua volta superato da un ritorno
alla forma accusatoria come conseguenza della caduta dell’impero e delle invasioni dei
popoli germanici. A partire dall’età medievale si è infine assistito quasi ovunque a una
massiccia affermazione del modello inquisitorio, sia per la maggiore corrispondenza
dello stesso alle forme di governo assolutistiche progressivamente sviluppatesi, sia per
l’autorevole influenza esercitata dalle procedure adottate dal diritto canonico. Pur con
molte varianti locali, il processo criminale risulta dunque riconducibile in quasi tutta
l’Europa del XVIII secolo ai medesimi fondamenti e alle medesime caratteristiche: a)
iniziativa del giudice ex officio, b) segretezza, c) scrittura, d) abbandono dell’accusa
privata (o sua trasformazione in querela).
A questo punto Renazzi affronta direttamente e, a differenza di Cremani, in modo
esplicito il problema della scelta tra accusa e inquisizione. La sua posizione è subito chiara;
il paragrafo XV della Diatriba, dove il tema viene trattato, porta infatti una eloquente
intitolazione: Difesa dell’uso del processo criminale odierno (Processus criminalis
hodierni usus defenditur).
Molteplici – osserva Renazzi – sono i motivi che spingono non pochi autori (per
tutti viene citato il nome di Christian Thomasius) a deplorare l’assoluta prevalenza del
ricorso alle forme inquisitorie. Tra le altre, molto diffusa appare l’opinione che tale tipo
di procedimento permetta a delatori e giudici di perseguitare impunemente l’innocenza,
offrendo ai primi l’opportunità di vessare qualsiasi cittadino, e ai secondi la possibilità
di ricorrere alla tortura senza il timore di dover poi subire le pene che nel sistema accu-
satorio proteggono dalle imputazioni calunniose.
La risposta di Renazzi a siffatte obiezioni si basa a suo dire sull’esperienza, che ha in-
segnato come il vigente sistema inquisitorio sia tutt’altro che esente da pecche, ma comporti
nondimeno più vantaggi che svantaggi sia per il bene pubblico che per quello privato.
10.9. Gli inconvenienti del modello accusatorio secondo Schmid D’Avenstein
Quest’ultima affermazione viene confortata con alcune considerazioni ricavate da Re-
nazzi dalla fresca lettura di un’opera intitolata Principes de la législation universelle,
pubblicata anonima nel 1776 (e con l’indicazione di Amsterdam come luogo di edizio-
ne) ma dovuta all’economista e giurista elvetico Georg Ludwig Schmid D’Avenstein,
autore assai vicino alle idee fisiocratiche che in Italia ha una certa influenza su alcuni
102