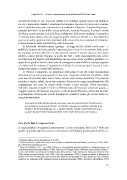Page 105 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 105
Capitolo 10 – Accusa e inquisizione nella dottrina dell’Età dei Lumi
secondo Beccaria, se non una pena inflitta a un cittadino quando ancora «si dubita se
sia reo o innocente», mentre l’esperienza ha insegnato che essa si presta solo a condan-
nare il «debole» innocente o ad assolvere il «robusto» colpevole. A questa «logica pro-
2
cessuale deforme» si dovrebbe invece sostituire, secondo Beccaria, il criterio morale
del libero convincimento, è cioè la libera valutazione delle prove mediante il «semplice
e ordinato buon senso», fino ad acquisire quella «certezza morale […] che determina
ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita» e che deve costituire il fondamen-
to della decisione sulla colpevolezza o sull’innocenza.
d) Pubblicità. «Pubblici siano i giudizi, – si legge nel Dei delitti e delle pene – e
pubbliche le prove del reato, perché l’opinione, che è forse il solo cemento delle socie-
tà, imponga un freno alla forza e alle passioni, perché il popolo dica noi non siamo
schiavi e siamo difesi». Dunque, la prova dei fatti e delle responsabilità deve essere
accertata non nel segreto dell’inquisizione ma nel corso di un «pubblico giudizio» e a
opera di un giudice «terzo». Non sono di conseguenza ammissibili le «accuse segrete»
e le delazioni; al contrario, l’imputato ha il diritto di conoscere tanto l’accusa e i suoi
fondamenti quanto i risultati dell’istruzione.
e) Celerità e semplicità. La «prontezza della pena» è uno dei valori fondamentali
del sistema di giustizia immaginato da Beccaria. Leggiamo infatti nel Dei delitti e delle
pene che «il processo deve essere finito nel più breve tempo possibile». Un processo
semplice e rapido, infatti, da un lato consente alla pena che segua immediatamente alla
commissione del reato di attuare nella società i suoi benefici effetti preventivi,
dall’altro risparmia lunghe e inutili sofferenze tanto all’imputato colpevole quanto, a
maggior ragione, all’imputato innocente. A tale proposito Beccaria, anche alla luce del-
la presunzione d’innocenza, prende decisamente posizione contro gli eccessi della car-
cerazione preventiva:
la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza se
non quando la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia d’un
cittadino finché sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente peno-
sa, deve durare il minor tempo possibile e dev’essere meno dura che si possa.
10.4. Paolo Risi, il «capocordata»
3
4
Il «capocordata» dei giuristi postbeccariani è, come accennato, Paolo Risi. Nella sua
qualità di giudice egli ben conosce i meccanismi dell’ordigno processuale di diritto co-
2 Cavanna, Storia del diritto moderno, 2, p. 218.
3 Stefano Solimano, Paolo Risi e il processo penale, in Studi di storia del diritto, 3, Milano, Giuffrè, 2001,
pp. 419-519, in particolare p. 517.
4 Paolo Risi (Milano 1731 - ivi 1800) è pretore a Pizzighettone quando pubblica le Animadversiones ad
criminalem jurisprudentiam (Milano 1766). Passa poi al Collegio fiscale di Milano come sindaco fiscale, e
in tale veste stende una relazione sull’abolizione della tortura e sulla limitazione della pena di morte. Nel
1786 diviene avvocato fiscale e dal 1789 e fino alla quiescenza (1791) è assessore presso il tribunale di
Milano. Nel 1791-92 partecipa con Beccaria alla redazione del progetto di codice penale per la Lombardia
austriaca. Le traduzioni delle Animadversiones in francese (Losanna 1768) e in tedesco (Heidelberg 1771)
95