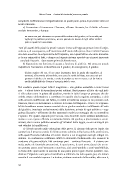Page 104 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 104
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
semplicità. Soffermiamoci telegraficamente su questi punti, prima di procedere oltre nel
nostro itinerario.
a) Presunzione di innocenza. Ciascuno, afferma Beccaria, ha il diritto «d’essere
creduto innocente», e dunque
un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può
togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i
patti coi quali le fu accordata.
Tutti gli assetti della giustizia penale ruotano invece sull’opposta presunzione di colpe-
volezza e, di conseguenza, sull’inversione dell’onere della prova. Non è infatti l’accusa
che deve accertare la colpevolezza dell’imputato, ma è quest’ultimo che deve dimostra-
re la sua estraneità ai fatti, e dunque nel vigente sistema «perché uno si provi innocente
– conclude Beccaria – deve essere prima dichiarato reo».
b) Separazione tra funzione di accusa e funzione di giudizio. Nel processo penale
inquisitorio l’accusatore si identifica con il giudice; di conseguenza, il giudice
diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai
tormenti, all’avvenire più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel pri-
gioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a
quella infallibilità che l’uomo s’arroga in tutte le cose.
Nel condurre questa impari lotta il magistrato – «un giudice assuefatto a voler trovar
rei» – è altresì dotato di straordinari poteri arbitrari. Basti pensare al fatto che «gli indi-
zi alla cattura sono in potere del giudice», mentre in tutta Europa un processo che do-
vrebbe essere «informativo» e consistere in «quello che la ragione comanda», e cioè
nella «ricerca indifferente del fatto», in realtà si trasforma sempre in un processo «of-
fensivo», inteso esclusivamente a ottenere la rovina dell’imputato. I fatti e le responsa-
bilità dovrebbero essere invece accertati da un giudice neutrale e indifferente all’esito
del giudizio, incaricato esclusivamente della decisione, privato di ogni arbitrio e – sug-
gerisce Beccaria – affiancato da due «assessori» scelti per sorteggio che ne controllino
l’operato. Per quanto riguarda poi l’accusa, essa dovrebbe essere affidata indifferente-
mente o a un organo ufficiale ovviamente distinto dal giudice, e precisamente a «com-
missari, che in nome pubblico accusino gl’infrattori delle leggi», ovvero ai singoli pri-
vati cittadini (al «pubblico»).
c) Criterio morale nella valutazione delle prove. Il sistema della prova legale che
caratterizza il processo penale di diritto comune culmina nella ricerca della confessione,
nella quale Beccaria individua «il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni cri-
minali». La confessione costituisce infatti lo strumento fondamentale che consente la
condanna alla pena edittale. Nel contempo però – continua Beccaria – il sistema am-
mette anche «le tiranniche presunzioni, le quasi prove, le semi-prove (quasi che un uo-
mo potesse essere semi-innocente o semi-reo, cioè semi-punibile e semi-assolvibile)»,
in forza delle quali anche in assenza di una piena prova legale diviene possibile con-
dannare l’imputato a una pena straordinaria e arbitraria. Su tutto questo, poi, «la tortura
esercita il suo crudele impero». La tortura, «infame crociuolo della verità», altro non è,
94