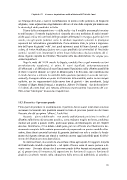Page 103 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 103
Capitolo 10 – Accusa e inquisizione nella dottrina dell’Età dei Lumi
no l’Europa dei Lumi, e anzi vi contribuiscono in modo a volte polemico, di frequente
originale, come espressione singolarmente efficace di una delle stagioni più intense nel-
la storia degli studi penalistici in Italia.
Il tema della contrapposizione – e della scelta – tra il modello processuale incentra-
to sull’accusa e il metodo inquisitorio si riannoda sia a una tradizione di radici umani-
stiche assai critica nei confronti delle procedure affermatesi in Europa a partire dal XIII
secolo, sia agli spunti polemici verso le strutture inquisitorie presenti in prestigiosi
esponenti del razionalismo giusnaturalista. Come abbiamo visto, la prima è rappresen-
tata dall’opera di giuristi ‘colti’, tra i quali spiccano i nomi di Pierre Ayrault e, in parti-
colare, di Anton Matthaeus (autore non a caso prediletto dai criminalisti di fine Sette-
cento); i secondi sono interpretati in primo luogo dalla netta e decisa condanna del si-
stema vigente espressa da Christian Thomasius nella sua dissertazione De origine pro-
cessus inquisitorii.
Dopo la metà del XVIII secolo la disputa, condotta fino a quel momento su toni
prevalentemente accademici, si anima di nuovi significati contemporaneamente
all’affermarsi e al diffondersi di una fiducia tutta illuministica nella effettiva possibilità
di reali e concrete riforme. Le opere di Montesquieu e di Beccaria, che contribuiscono
in modo decisivo a indicare la centralità della questione penale (e in essa dei temi pro-
cessuali), divengono allora un punto di riferimento irrinunciabile, anche se non sempre
esplicito, per tre rappresentanti della nuova leva di giuristi – due accademici, Luigi
Cremani e Filippo Maria Renazzi, e un pratico, Alberto De Simoni – che in alcuni lavo-
ri risalenti alla metà degli anni Settanta affrontano espressamente l’argomento del con-
flitto ormai ‘ideologico’ tra accusa e inquisizione.
10.3. Beccaria e il processo penale
Prima però di prendere in considerazione il pensiero dei tre autori testé citati conviene
accennare brevemente alle posizioni assunte in tema di processo penale sia da Cesare
Beccaria che dal suo primo ‘allievo’, Paolo Risi.
Beccaria – giova sottolinearlo – non prende esplicitamente posizione in ordine al
dibattito sulla forma del processo penale e, come vedremo meglio tra breve, preferisce
rinviare sul punto a quanto scritto, pochi anni prima, da Montesquieu nel De l’Esprit
des lois. Nondimeno, il Dei delitti e delle pene, pur non offrendo una illustrazione tec-
nicamente compiuta della materia processuale né proponendo un preciso modello alter-
nativo, fissa alcuni essenziali principi di garanzia destinati non solo a erodere le fonda-
menta del vigente sistema ma altresì a costituire ancora oggi ineludibili punti di riferi-
mento del dibattito processualpenalistico.
In estrema sintesi, muovendo da una serrata critica agli aspetti di maggiore iniquità
del tradizionale modello inquisitorio – nel quale «l’uomo cessa di essere persona e di-
venta cosa» – Beccaria ritiene che il processo penale debba basarsi sui seguenti princi-
pi: a) presunzione di innocenza; b) separazione tra funzione di accusa e funzione di
giudizio; c) criterio morale nella valutazione delle prove; d) pubblicità; e) celerità e
93