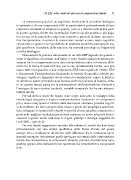Page 69 - Stefano Rastelli (a cura di), La ricerca sperimentale sul linguaggio: acquisizione, uso, perdita, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 69
Gli ERP nello studio dei processi di comprensione frasale 51
La costruzione quindi di un significato funzionale di un indice fisiologico
in generale e di una componente ERP in particolare è principalmente di tipo
empirico e cumulativo: empirico in quanto, come si è chiarito nella prima parte
di questo capitolo, il fatto che il potenziale elettrico sia più positivo o più nega-
tivo in una certa zona dello scalpo non consente a priori di dedurre una speci-
fica interpretazione in termini di meccanismi neurali e tanto meno cognitivi;
cumulativo in quanto l’accumulazione di evidenze empiriche permette di me-
glio specificare il carattere della relazione fra costrutti psicologici (e linguistici)
e indice fisiologico.
Chiaramente la potenza inferenziale di un dato ERP dipende da quanto e
come il significato funzionale dell’indice è stato chiarito dalla letteratura pre-
cedente. Se in un esperimento una data manipolazione mette in luce una diffe-
renza fra le forme d’onda ERP che, per le sue caratteristiche fisiche, non può
essere fatto corrispondere a una componente ERP nota si parla di ‘effetto’ ERP
e chiaramente l’interpretazione funzionale in termini di specifici costrutti psi-
cologici, cognitivi o linguistici dovrà essere necessariamente vaga e le inferen-
ze dovranno essere principalmente fondate sull’informazione di latenza, ovve-
ro su quanto tempo passa fra la presentazione dell’informazione rilevante e
l’emergere di una reazione cerebrale, variabile temporale che ha una interpre-
tabilità diretta.
Per tali motivi, studi che hanno come scopo non tanto lo sviluppo della
metodologia (scoperta o miglior caratterizzazione funzionale di componenti
più o meno note) quanto l’utilizzo della tecnica per studiare i processi cogniti-
vi dovrebbero, fin dal momento della messa a punto del paradigma sperimen-
tale, sviluppare le ipotesi dello studio in termini di una specifica componente e
porsi nelle migliori condizioni per poterla misurare in modo adeguato (relati-
vamente a questo molto utili sono le regole, principi e strategie suggerite da
Luck 2005, Capitolo 2).
Per uno studio organizzato secondo tale schema la analisi dei dati inizia
primariamente con una analisi qualitativa delle forme d’onda del grand-
average, atta a verificare se all’interno delle differenze fra le condizioni speri-
mentali emergono visivamente quelle ipotizzate in termini delle caratteristiche
fisiche che caratterizzano le componenti (latenza, polarità, distribuzione topo-
grafica) oppure altre deflessioni non ipotizzate ma riconducibili a componenti
note.