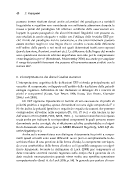Page 66 - Stefano Rastelli (a cura di), La ricerca sperimentale sul linguaggio: acquisizione, uso, perdita, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 66
48 F. Vespignani
possono invece risultare dovuti anche ad artefatti del paradigma e a variabili
linguistiche e cognitive non considerate con sufficiente attenzione durante la
messa a punto del paradigma. Un ulteriore corollario delle osservazioni svi-
luppate in questo paragrafo è che alcuni fenomeni linguistici non possano es-
sere studiati in modo adeguato e valido con l’utilizzo delle tecniche ERP per-
ché i limiti del paradigma non lo consentono, e che taluni fenomeni possono
essere studiati meglio in una lingua che in un’altra a causa delle differenze
nell’ordine delle parole o nei modi nei quali determinati tratti sono espressi
(parole funzione, flessioni, morfemi etc.). Le differenze delle lingue del mondo
sono quindi una risorsa di estrema importanza non solo per la comparazione
cross-linguistica per sé (Bornkessel, Schlesewsky 2006) ma anche per ampliare
il range dei possibili fenomeni che possano efficacemente essere studiati con la
tecnica ERP.
6. L’interpretazione dei dati e l’analisi statistica
L’interpretazione cognitiva delle deflessioni ERP si fonda principalmente sul
concetto di componente, sviluppato nell’ambito della tradizione della psicofi-
siologia cognitiva. All’interno di tale tradizione si distingue fra i concetti di
picchi e componenti (Kutas, Van Petten 1994; Kutas, Van Petten, Kluender
2006; Luck 2005).
Gli ERP appaiono tipicamente in termini di una successione di picchi di
polarità positiva e negativa, spesso denominati con una sigla composta da P o
N che indica la polarità (positiva o negativa) e seguita da numeri che possono
corrispondere all’ordine nella sequenza (P1, N1, P2 etc.) o alla latenza in ms
dall’evento critico (N200, P200, N400, P600…). La stessa nomenclatura è spesso
usata anche per indicare le corrispondenti componenti le quali possono essere
denominate anche con sigle che si riferiscono ad altre caratteristiche o al signi-
ficato funzionale delle stesse (per es. MMN Mismatch Negativity, LAN Left An-
terior Negativity etc.).
Anche se la nomenclatura non distingue chiaramente fra picchi e compo-
nenti questi concetti sono assai differenti: se un picco è semplicemente la de-
scrizione fisica di una porzione della forma d’onda, la componente corrispon-
de a una caratteristica della forma d’onda a cui è possibile assegnare un signi-
ficato funzionale. Secondo la definizione di Luck (2005) per componente si
deve intendere «Attività neurale registrata sullo scalpo che è generata da un
dato modulo neuroanatomico quando viene svolta una specifica operazione
computazionale» (trad. it. da Luck 2005, p. 59). In generale per parlare di com-