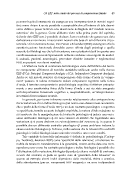Page 67 - Stefano Rastelli (a cura di), La ricerca sperimentale sul linguaggio: acquisizione, uso, perdita, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 67
Gli ERP nello studio dei processi di comprensione frasale 49
ponente è quindi necessario sia assegnata una interpretazione in termini cogni-
tivi; meno chiaro è se sia possibile o auspicabile che all’interno di tale descri-
zione debba o possa rientrare una descrizione dettagliata del ‘modulo neuroa-
natomico’ che la genera. Come abbiamo visto nella prima parte del capitolo,
dal solo dato ERP non è possibile dedurre l’area cerebrale che genera una data
deflessione e nemmeno i meccanismi neurali alla base di tali differenze di po-
tenziale. Ciò nonostante Kutas, Van Petten e Kluender (2006) sostengono che la
caratterizzazione funzionale dovrebbe essere offerta dagli psicologi e quella
neurale dai fisiologi ma che tali circostanze sono piuttosto ideali in quanto una
caratterizzazione neurale tipicamente richiede evidenze convergenti da model-
li animali, pazienti neurologici, procedure cliniche invasive e registrazioni
EEG su pazienti con danni cerebrali.
Un’ulteriore fonte di confusione terminologica viene dall’utilizzo del termi-
ne componente all’interno di tecniche statistiche utilizzate anche nella ricerca
ERP (PCA: Principal Component Analysis o ICA: Independent Component Analysis).
Anche se tali metodi statistici di scomposizione delle forme d’onda in ‘compo-
nenti’ possono in talune circostanze isolare componenti cognitive nella forma
d’onda, il termine componente in psicofisiologia cognitiva si riferisce primaria-
mente a una caratteristica fisica della forma d’onda a cui sia stata assegnata
un’interpretazione funzionale cognitiva e, auspicabilmente, un’interpretazione
in termini di meccanismo neurale.
In generale, per trarre inferenze corrette relativamente alla corrispondenza
fra la variazione di un indice fisiologico (nel nostro caso determinate caratteristi-
che o picchi delle forme d’onda ERP) e un dato costrutto psicologico o cognitivo
va specificata, tramite accurate indagini empiriche, la natura di tale relazione: se
si è mostrato che la manipolazione del costrutto psicologico ψ induce una varia-
zione dell’indice fisiologico φ ciò non consente di inferire che registrando una
variazione φ si possa dedurre un coinvolgimento del costrutto ψ, in quanto è
possibile che un differente costrutto psicologico ψ’ possa anch’esso indurre la
stessa reazione fisiologica φ. In breve, nulla assicura che le relazioni fra costrutti
psicologici e indici fisiologici siano univoche o molti-a-uno o uno-a-molti.
Tale variabile del modello inferenziale è definita in psicofisiologia (Caciop-
po, Tassinary, Brentson 2007) come ‘specificità della relazione’, un’ulteriore va-
riabile da tenere in considerazione è la generalità, ovvero anche data una corri-
spondenza uno-a-uno fra costrutto psicologico e indice fisiologico è possibile che
l’elicitazione della variazione fisiologica dipenda da alcune variabili di contorno,
ovvero dal contesto; si parla in questo caso di ‘generalità della relazione’ in
quanto ad esempio alcuni indici dipendono dalla modalità, visiva o acustica,
della stimolazione (per es. componenti ERP esogene) o ne sono indipendenti