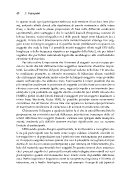Page 58 - Stefano Rastelli (a cura di), La ricerca sperimentale sul linguaggio: acquisizione, uso, perdita, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 58
40 F. Vespignani
In questo modo ogni partecipante vede una sola versione di un dato item (fra-
se), evitando effetti dovuti alla ripetizione di parole contenute o della intera
frase, e inoltre vede le stesse proporzioni di frasi nelle differenti condizioni
sperimentali; altro vantaggio è che le variabili lessicali (frequenza, numero di
lettere, fonemi, vicini ortografici etc.) delle parole target sono bilanciate fra i
soggetti. Il fatto che il bilanciamento delle variabili lessicali avvenga fra i sog-
getti e non sul singolo soggetto è in qualche modo problematico in quanto un
soggetto che vede la lista 1 è possibile mostri maggiori effetti negli ERP della
lunghezza o della frequenza rispetto a un soggetto della lista 2, sia per fattori
cognitivi che per fattori individuali legati alla morfologia e alle caratteristiche
elettriche dell’encefalo.
Per tale motivo è importante che il numero di soggetti non sia troppo pic-
colo in modo che tali differenze inter-soggettive casuali non diventino impor-
tanti. La scelta all’interno del pool di quali frasi vadano nella lista 1 in una da-
ta condizione permette, se ritenuto necessario, di bilanciare alcune variabili
che si ritengono importanti anche a livello del singolo soggetto, come potrebbe
essere nell’esempio che abbiamo visto l’animatezza: è infatti possibile che sia
più semplice analizzare in posizione di soggetto a inizio frase un nome che si
riferisce a un ente animato (gatto, cane, ragazzo) rispetto a un inanimato (me-
stolo) che è più probabile sia oggetto diretto o indiretto (si è infatti rilevato che
l’N400 a parità di altri fattori lessicali è maggiore per un soggetto inanimato a
inizio frase, Weckerly, Kutas 1999). Se possibile potrebbe essere conveniente
controllare che all’interno di una lista non appaia un numero sproporzionato
di inanimati in condizione di violazione e di animati in condizione corretta.
Chiaramente il disegno a quadrato latino fa sì che in una differente lista la
proporzione sia rovesciata ma tali differenze introducono comunque delle ul-
teriori differenze fra i soggetti (rumore, varianza non spiegata dalla manipola-
zione), rendendo più difficile ottenere risultati significativi con un numero
limitato di partecipanti.
Utilizzando questo disegno sperimentale, la motivazione a raccogliere da-
ti da più partecipanti non ha tanto come scopo validare i risultati a livello in-
ter-soggettivo o di popolazione ma è piuttosto uno stratagemma per aumenta-
re il rapporto segnale rumore (stante che non è plausibile raccogliere dati per
decine di ore da uno stesso partecipante) e per ottenere un bilanciamento glo-
bale del materiale sperimentale fra i soggetti. In questo senso si deve assumere
che i processi cognitivi e i potenziali evocati sotto indagine siano simili nei vari
partecipanti e quindi il reclutamento deve tenere conto di possibili differenze
sia a livello cognitivo e linguistico come la competenza linguistica e il livello di
istruzione, sia a livello fisiologico, come ad esempio il range di età (special-