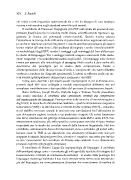Page 16 - Stefano Rastelli (a cura di), La ricerca sperimentale sul linguaggio: acquisizione, uso, perdita, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 16
XIV S. Rastelli
chi inizia a fare linguistica sperimentale sia a chi ha bisogno di una rassegna
concisa e informativa sugli standard scientifici più recenti.
Il contributo di Francesco Vespignani (Gli ERP nello studio dei processi di com-
prensione frasale) descrive in maniera molto chiara, scientificamente rigorosa e ag-
giornata la tecnica dei potenziali evento-correlati. Questa tecnica misura
l’evoluzione nel tempo delle differenze di potenziale elettrico registrate sullo scal-
po anche in relazione a stimoli linguistici. L’autore descrive ampiamente gli aspetti
tecnici relativi all’estrazione e alla ripulitura del segnale e anche i risvolti scientifi-
co-metodologici degli ERP, nonché i vantaggi e gli svantaggi del loro utilizzo per
lo studio del linguaggio. Tra i vantaggi evidenti vengono annoverati l’alta risolu-
zione temporale e la multidimensionalità degli indici. Gli svantaggi sono dovuti
invece per esempio alla metodologia di averaging. Molto risalto è dato anche alla
descrizione dei paradigmi per lo studio della comprensione frasale e
all’interpretazione delle diverse forme d’onda o ‘componenti’, che tanto dibattito
continua a suscitare tra i linguisti sperimentali. L’autore si sofferma anche sui me-
todi statistici principalmente utilizzati per analizzare i dati ERP.
Infine, sono descritti i principali quadri interpretativi in cui le diverse com-
ponenti dagli ERP sono collegate a moduli neurocognitivi differenti che nel
complesso contribuiscono a fasi specifiche del processo di comprensione frasale.
Zaira Cattaneo, Joseph Devlin, Carlotta Lega e Tomaso Vecchi presentano
uno studio intitolato Il contributo della stimolazione cerebrale alla comprensione
dell’organizzazione del linguaggio. Diversamente dalle tecniche di neuroimmagine e
dagli ERP, le tecniche di stimolazione cerebrale – quali la stimolazione magnetica
transcranica (TMS) o la stimolazione a correnti dirette continue (tDCS) – consento-
no di stabilire un nesso causale (e non solo una correlazione) tra l’attivazione in
una determinata regione cerebrale e un particolare compito. Gli autori forniscono
una breve descrizione dei principi di funzionamento della TMS e della tDCS. Suc-
cessivamente analizzano più nello specifico come queste tecniche si siano rivelate
importanti per lo studio dei correlati neurali delle funzioni linguistiche. Nel loro
contributo, estremamente denso di informazioni, ricco e articolato, gli autori sotto-
lineano come la TMS si sia dimostrata uno strumento utilissimo non solo per
mappare le singole funzioni percettive, attentive o cognitive, ma anche per traccia-
re una ‘cronometria’ del contributo di diverse aree cerebrali in un determinato
processo cognitivo (linguaggio compreso).
Il contributo di Stefano Cappa (La neuropsicologia del linguaggio: il contributo
della patologia) spiega come – nonostante gli sviluppi delle tecniche di indagine del
funzionamento cerebrale in condizioni di normalità – lo studio della patologia del
linguaggio mantenga inalterato il suo ruolo centrale nella ricerca sulla neurobiolo-
gia del linguaggio, sia come generatore di ipotesi che come terreno di verifica di