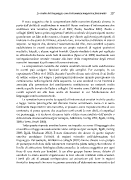Page 145 - Stefano Rastelli (a cura di), La ricerca sperimentale sul linguaggio: acquisizione, uso, perdita, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 145
Lo studio del linguaggio con la risonanza magnetica funzionale 127
È stato suggerito che la comprensione delle narrative dipenda almeno in
parte dall’abilità di suddividere in eventi il flusso continuo d’informazione che
costituisce una narrativa (Zacks et al. 2007; Zacks, Swallow 2007). Zacks e
colleghi (2001) hanno prima registrato l’attività cerebrale dei partecipanti mentre
guardavano un film nello scanner, e hanno poi chiesto agli stessi partecipanti di
indicare in che punti del filmato, secondo loro, la narrativa si divideva in eventi
separati. Le regioni che, durante l’osservazione del film, sono sensibili a questa
suddivisione in eventi costituiscono un ampio network di regioni posteriori
mediali e laterali, e alcune regioni frontali. Questo risultato è stato poi replicato
in altri studi che hanno usato testi di narrativa (Speer et al. 2009) mostrando così
un’organizzazione neurale comune alla base della comprensione degli eventi
narrativi trasmessi da più mezzi di comunicazione.
Le computazioni condotte dai sistemi cerebrali coinvolti nella suddivisione
in eventi può svolgere funzioni anche più semplici. Per esempio, in un
esperimento (Tobia et al. 2012), durante l’ascolto di una serie di toni il cui livello
di ordine variava nel tempo, i partecipanti indicavano quando percepivano un
cambiamento nella regolarità della sequenza. Le aree cerebrali in cui l’attività è
associata alla percezione del cambiamento costituiscono un network molto
simile a quello trovato da Zacks e colleghi. Ciò mostra come l’abilità di percepire
eventi separati sia alla base anche di funzioni in cui l’elaborazione del
linguaggio non ha nessun ruolo.
Le narrative hanno anche la capacità di indurre stati emotivi in chi le ascolta
o legge. Teorie psicologiche del discorso hanno sottolineato come ci si senta
facilmente trasportati in una narrativa, si possano avere risposte emotive al suo
contenuto, si possa sperare che accadano certi eventi (e non altri), si empatizzi
coi personaggi, o ci si ritrovi di umore triste o felice come risultato dell’ascolto o
della lettura di una narrativa (per esempio, Allbritton, Gerrig 1991; Egidi, Gerrig
2009; Green, Brock 2000).
Tutte queste risposte emotive hanno un impatto su come il linguaggio che
si ascolta o si legge successivamente viene compreso (per esempio, Egidi, Gerrig
2009; Egidi, Nusbaum 2012). È stato dimostrato che alcune di queste risposte
emotive modulano l’attività di regioni coinvolte nell’elaborazione del
linguaggio. Per esempio, Wallentin e colleghi (2011) hanno chiesto a un gruppo
di partecipanti di dare delle valutazioni numeriche (dette rating) che indicano il
livello di attivazione fisiologica (detta arousal) e la valenza soggettiva per ogni
frase di una storia per bambini. A un altro gruppo hanno invece chiesto di
ascoltare la storia mentre registravano la loro attività cerebrale nello scanner.
Livelli più alti di arousal corrispondono ad attivazione più forte in regioni
frontali e temporali che sono in genere associate all’elaborazione semantica del