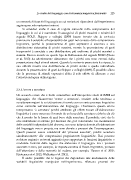Page 143 - Stefano Rastelli (a cura di), La ricerca sperimentale sul linguaggio: acquisizione, uso, perdita, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 143
Lo studio del linguaggio con la risonanza magnetica funzionale 125
un network di base del linguaggio su cui variazioni dipendenti dall’esperimento
aggiungono solo variazioni minori.
Si consideri anche il caso di regioni coinvolte nella comprensione del
linguaggio in cui si è esaminato il susseguirsi di picchi massimi e minimi del
segnale BOLD. Skipper e colleghi (2009) hanno trovato che la corteccia
premotoria è sensibile all’espressività dei gesti nel contesto della comprensione
linguistica, perché la presentazione di gesti espressivi è associata a una
distribuzione sistematica di picchi massimi, mentre la presentazione di gesti
inespressivi è associata a una distribuzione più uniforme di picchi massimi e
minimi. Ricerca recente su questo tipo di fluttuazioni del segnale BOLD (Davis
et al. 2013) ha ulteriormente dimostrato che i picchi non sono evocati dalla
presentazione degli stimoli esterni. Quando la corteccia premotoria è a riposo, la
sua attività mostra una distribuzione di picchi simile a quella individuata
durante la presentazione di gesti da Skipper e colleghi (2009). È possibile allora
che la presenza di stimoli espressivi abbia il solo effetto di allineare a essi
l’attività endogena della regione.
2.3. L’errore a serratura
Un secondo errore che è facile commettere nell’interpretare studi di fMRI sul
linguaggio, che chiameremo ‘errore a serratura’, consiste nella tendenza a
considerare regioni la cui attivazione si correla con un certo processo linguistico
come coinvolte nell’elaborazione del linguaggio. Chiamiamo questo errore
interpretativo ‘a serratura’ perché attribuire gli effetti trovati all’elaborazione
linguistica è come osservare il mondo da un buco della serratura e inferire da ciò
che il mondo ha la forma di quel buco della serratura. È possibile, cioè, che le
aree individuate si attivino per funzioni che, pur coincidendo con modulazioni
delle variabili indipendenti del discorso, non sono tuttavia dovute all’elaborazione
del linguaggio vera e propria, ma sono dovute a processi che l’accompagnano.
Questi possono essere considerati dei ‘processi associati’, poiché accadono
simultaneamente alle computazioni propriamente linguistiche. Essi possono
reclutare regioni o network aggiuntivi per supportare le funzioni linguistiche o
modulare l’attività delle regioni che elaborano il linguaggio. Fra i processi
associati ci sono, per esempio, le risposte emotive al flusso linguistico, processi
dell’attenzione o della memoria (si vedano, per esempio, Hasson et al. 2007;
Kristensen et al. 2012; Wallentin et al. 2011).
È anche possibile che le regioni che rispondono alle modulazioni delle
variabili linguistiche manipolate nell’esperimento, riflettano processi che