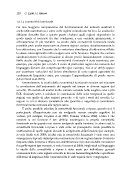Page 138 - Stefano Rastelli (a cura di), La ricerca sperimentale sul linguaggio: acquisizione, uso, perdita, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 138
120 G. Egidi, U. Hasson
1.6. La connettività funzionale
Per una maggiore comprensione del funzionamento dei network cerebrali è
anche utile esaminare se e come varie regioni comunicano fra loro. Le analisi che
abbiamo descritto fino a questo punto rivelano quali regioni rispondono in
modo simile al contrasto fra due condizioni, a una variabile sperimentale, o
all’interazione di più variabili. Lo studio della connettività funzionale rende
possibile però anche esaminare se diverse regioni variano simultaneamente la
loro attivazione, con l’assunto che la variazione simultanea di attivazione riflette
lo stesso coinvolgimento nello svolgere una certa funzione. Regioni che variano
simultaneamente la loro attivazione si dicono perciò funzionalmente connesse.
Nello studio del linguaggio, la connettività funzionale è stata esaminata, per
esempio, per capire più a fondo il ruolo di particolari regioni dei network del
linguaggio durante dei compiti specifici (per esempio, Yue et al. 2013) oppure
per esaminare variazioni nel lavoro simultaneo di certe regioni apportate da
cambiamenti linguistici come, per esempio, l’apprendimento di parole nuove
(Ghazi Saidi et al. 2013).
Generalmente, lo studio della connettività funzionale consiste nel misurare
la correlazione dell’andamento del segnale nel tempo in diverse regioni del
cervello. Un metodo di analisi molto comune consiste nello scegliere una o più
ROI, chiamate seme, e calcolare le correlazioni delle serie temporali in quelle
regioni con quelle di altre regioni prescelte o di tutti i voxel del cervello. Le
regioni in cui si rilevano correlazioni alte (positive o negative) si considerano
funzionalmente connesse alle regioni seme.
È anche possibile calcolare la connettività funzionale a riposo, quando cioè il
partecipante all’esperimento non sta svolgendo nessun compito cognitivo (si
vedano, per esempio, Koyama et al. 2010; Tomasi, Volkow 2012). L’idea è che
network la cui funzione è ben definita mantengono la propria connettività
funzionale anche quando non stanno svolgendo quella funzione. In alcuni casi, la
connettività funzionale a riposo è vista come un prerequisito: rende possibile la
coattivazione di quelle regioni durante lo svolgimento della funzione (per esempio,
si veda Smith et al. 2009). In altri casi, la connettività funzionale è vista come una
conseguenza: dipende dalla ripetuta coattivazione di certe regioni durante l’esercizio
frequente della funzione e riflette una stabilizzazione così ottenuta delle connessioni
fra quelle regioni (per esempio, si veda Hasson et al. 2009). Negli studi sul linguaggio
lo studio della connettività a riposo è stato usato per individuare generali
connessioni fra le varie regioni coinvolte in diverse funzioni linguistiche e specificare
differenze di ampiezza delle connessioni fra le varie regioni che le compongono.