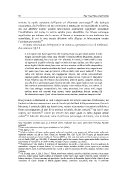Page 70 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 70
58 Rita Degl’Innocenti Pierini
63
avvicina la rapida caricatura dell’ignoto ed effeminato personaggio alla tipologia
mecenatiana, che Porfirione nel suo commento ci attesta, pur non accreditando la notizia,
che sub Malthini nomine quidam Maecenatem suspicantur significari; nonostante
l’isosillabismo del nome, la notizia sembra poco attendibile, ma rimane comunque
significativa per indicare che le accuse di Seneca si inseriscono in una tradizione ben
consolidata, di cui la nota traccia difensiva nelle Elegiae in Maecenatem mostra
64
l’evidente pervasività.
Il ritratto mecenatiano dell’epistola 114 continua a presentarsi ricco di emblemati-
che notazioni: §§ 6-8
6. non statim cum haec legeris hoc tibi occurret, hunc esse qui solutis tunicis in urbe
semper incesserit (nam etiam cum absentis Caesaris partibus fungeretur, signum a
discincto petebatur); hunc esse qui
sic apparuerit ut pallio velaretur caput exclusis utrimque auribus, non aliter quam in
mimo fugitivi divitis solent; hunc esse cui tunc maxime civilibus bellis strepentibus
et sollicita urbe et armata comitatus hic fuerit in publico, spadones duo, magis tamen
viri quam ipse; hunc esse qui uxorem milliens duxit, cum unam habuerit? 7. Haec
verba tam inprobe structa, tam neglegenter abiecta, tam contra consuetudinem
omnium posita ostendunt mores quoque non minus novos et pravos et singulares
fuisse. Maxima laus illi tribuitur mansuetudinis: pepercit gladio, sanguine abstinuit,
nec ulla alia re quid posset quam licentia ostendit. Hanc ipsam laudem suam corrupit
istis orationis portentosissimae delicis; apparet enim mollem fuisse, non mitem. 8.
Hoc istae ambages compositionis, hoc verba transversa, hoc sensus miri, magni
quidem saepe sed enervati dum exeunt, cuivis manifestum facient: motum illi
felicitate nimia caput. Quod vitium hominis esse interdum, interdum temporis solet.
Non potendo soffermarmi su tutti i singoli snodi del ritratto senecano di Mecenate, mi
limiterò ad alcune osservazioni: uno dei tocchi più brillanti della presentazione fisica di
Mecenate è costituito dalla sua descrizione, mentre si presenta in occasioni pubbliche a
65
Roma accompagnato, al pari di un sovrano orientale, da due eunuchi, ma con il capo
66
coperto dal mantello, tranne gli orecchi non aliter quam in mimo fugitivi divitis
67
solent. Il fatto che Mecenate, come il più basso personaggio del mimo, viva in strada
nunc Buccillum: proinde esset ac si hircum oleret, Gargonii loco esset, quem idem Horatius Buccillo
opposuit.
63 Esauriente trattazione della figura di Maltino in Citti (1996).
64 Vd. supra, n. 45.
65 Infatti si trattava di figure molto presenti nelle corti orientali e poi sempre più diffuse anche nella corte
imperiale romana: vd. per es. Svet. Claud. 28. Secondo Xen. Cyr. 7,5,65 Ciro II usava gli eunuchi come
attendenti personali per la loro lealtà, vd. Brosius (2007, p. 26): così sarà anche nel tardo impero romano, su
cui vd. Smith (2007, pp. 202-208). L’elemento della qualità dei comites faceva parte anche della ritrattistica
ciceroniana: si veda per es. il Clodio di Mil. 28 nullis Graecis comitibus, ut solebat.
66 Naturalmente l’atto implica il desiderio di nascondersi, ma anche, a mio parere, di avere qualcosa da
nascondere: vengono in mente Petron. 7,6 execratus itaque aniculae insidias operui caput et per medium
lupanar fugere coepi in alteram partem; Iuv. 6,118 s. sumere nocturnos meretrix Augusta cucullos / ausa
Palatino.
67 Vd. Frontin. strat. 4,1,26 L. Piso C. Titium praefectum cohortis, quod loco fugitivis cesserat, cinctu togae
praeciso, soluta tunica, nudis pedibus in principiis cotidie stare, dum vigiles venirent, iussit, conviviis et
balneo abstinere. Il testo senecano qui riprodotto è quello accolto da Reynolds: fugitivi divitis è frutto di una
correzione di Lipsio rispetto al tràdito fugitivi divites, correzione necessaria, dato che il confronto