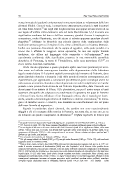Page 62 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 62
50 Rita Degl’Innocenti Pierini
venga invocata dai gaudenti contemporanei come patrocinium ac velamentum delle loro
più turpi libidini. Come si vede, i contesti sono estremamente polemici e tutti incentrati
22
sul tema della luxuria, ma negli altri luoghi senecani non appare alcuna traccia di un
uso legato all’ambito critico-letterario: solo nel tardo Macrobio Sat. 5,1,5 troviamo una
significativa conferma del tono e dell’uso senecano, giacché il nesso è impiegato in
connessione, molto illuminante, con chi siccus et sobrius apprezza quaedam dicendi
23
frugalitas. Abbiamo da Macrobio una piccola riprova della continuazione della
tradizione senecana per cui il regime di vita viene a identificarsi col sistema letterario.
Inoltre non possiamo dimenticare che la coppia di aggettivi, nella quale peraltro è a
siccus che è affidata la maggiore carica espressiva, ha una sua seppur limitata
24
tradizione, che affiora nel linguaggio della commedia e dell’epigramma, non
casualmente confermata dalla significativa presenza in una memorabile pennellata
25
descrittiva di Fortunata, la sposa di Trimalchione, nella cena petroniana 37,7: est
sicca, sobria, bonorum consiliorum.
Credo che sia opportuno a questo proposito aprire una breve parentesi per ricor-
dare come un’evidente convergenza tematica sulla degenerazione della letteratura
lega la nostra lettera 114 ai primi capitoli pervenutici del romanzo di Petronio, dove
prima Encolpio descrive e denuncia i vizi della scuola di retorica contemporanea, poi
Agamennone, pur approdando a conclusioni più difensive, pone comunque anche lui
sotto accusa un sistema educativo ormai degenerato nei valori complessivi: si è anche
pensato a una precisa fonte stoica da cui Petronio dipenderebbe, dato l’accordo con
alcuni passi di un trattato di Filone, il De plantatione, ma per il nostro scopo ci basti
osservare che quello che colpisce e va sottolineato è la presenza nei passi di Petronio
e Seneca di una ricerca stilistica e di un linguaggio critico, che si segnala per la pre-
26
senza, accanto a terminologia retorica di tradizione e matrice ciceroniana, di imma-
gini e di metafore nuove e concrete, non dissimili sia concettualmente che sul piano
della resa formale ed espressiva.
Segnalo in particolare alcuni elementi, che peraltro non sono occasionalmente
sfuggiti a chi si è occupato della retorica in Petronio, ma senza che, se non erro, se ne
27
sia delineato un quadro complessivo di riferimenti: l’inflata explicatio di Seneca può
22
Su questi fenomeni degenerativi legati alla luxuria, cfr. soprattutto Citroni Marchetti (1991, p. 116 ss.).
23 Cfr. Senecio in epist. 101,3 hic homo summae frugalitatis, non minus patrimonii quam corporis diligens.
24
In una togata di Afranio si riferisce a tradizionali virtù femminili (com. 61 ss. vigilans ac sollers, sicca sana
sobria: / virosa non sum, et si sum, non desunt mihi / qui ultro dent: aetas integra est, formae satis), in un
epigramma di Marziale 12,30,1 s. alla morigeratezza di un amico: Siccus, sobrius est Aper; quid ad me? /
Servum sic ego laudo, non amicum.
25 Per un’analisi del contesto, vd. Salanitro (1990, p. 23 ss.).
26 Vd. gli esempi addotti da Fedeli (2007, p. 87), ma già anche Soverini (1985, p. 1714 n. 27); utili confronti
leggiamo anche in Codoñer (1990).
27 Non ne tiene conto, mi pare, Soverini (1985) nella sua ben documentata rassegna (vd. per es. p. 1713 s.):
anche il recente commento di Breitenstein (2009) non cita l’epistola 114 di Seneca. Solo qualche breve
citazione dell’epistola, senza precisi confronti, vedo ora anche nell’utile commento complessivo di Schmeling
(2011). Altri termini che implicano, a mio parere, una certa sintonia tematica ed espressiva tra i due testi sono
regula (epist. 114,13 adice nunc quod oratio certam regulam non habet: consuetudo illam civitatis, quae
numquam in eodem diu stetit, versat e Petron. 2,7 nuper ventosa istaec et enormis loquacitas Athenas ex Asia
commigravit animosque iuvenum ad magna surgentes veluti pestilenti quodam sidere adflavit, semelque
corrupta regula eloquentia stetit et obmutuit); marcent (epist. 114,23 cum vero – scil. animus – cessit