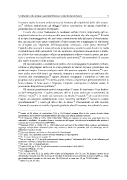Page 21 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 21
La filosofia come terapia, autotrasformazione e stile di vita in Seneca 9
Possiamo capire la severa critica mossa da Frontone alla ripetitività dello stile seneca-
64
no, sebbene naturalmente gli sfugga l’intima connessione tra questa ripetitività e
gl’intenti etici ed educativi del filosofo.
È ovvio che, come l’admonitio, la meditatio verbale ricorre ampiamente agli ac-
65
corgimenti retorici che si rivolgono alle emozioni piuttosto che alla ragione. Si tratta
di un tipo di autosuggestione che può essere estremamente utile dal punto di vista terapeu-
tico, ma non può certo essere considerato «l’unico mezzo atto a raggiungere la vita beata»
66
né «l’aspetto più importante dell’insegnamento senecano», come pensa Newman;
l’appello alle emozioni è essenzialmente propedeutico, mentre la meta finale è in realtà
il ristabilimento della razionalità. Ciò che conferisce importanza alla meditatio è piutto-
sto il fatto che essa non mira a offrire un momentaneo sollievo contro la paura, ma piut-
67
tosto a produrre una trasformazione spirituale permanente, che permetterà di passare
allo stadio successivo della terapia.
Gli esercizi pratici, o parzialmente pratici, che accompagnano la meditatio verbale,
sebbene si propongano anch’essi lo scopo primario di vincere la paura, possiedono una
68
portata più ampia. Possono rivolgersi anche alla passione opposta: il desiderio; e pos-
sono anche avere altri scopi: per esempio, imparare a concentrarsi in un ambiente sfa-
69
vorevole alla concentrazione, oppure alternare compagnia e solitudine in vista del
70
progresso etico personale. In ultima analisi, mirano a trasformare permanentemente la
bona voluntas in bona mens e l’impetus, l’impulso contingente, in habitus animi, la
71
permanente disposizione spirituale.
Gli esercizi parzialmente pratici comprendono l’esame di coscienza e l’uso fruttuo-
so dell’immaginazione. L’esame senecano dell’io è stato analizzato in profondità da
73
72
Alfonso Traina e in modo più sommario da Michel Foucault. Qui considereremo
74
l’esame di coscienza esclusivamente come ‘esercizio spirituale’. Seneca lo pratica
75
76
quotidianamente e esorta gli altri a fare lo stesso. Diversamente da altri esercizi,
l’esame di coscienza è rivolto al passato piuttosto che all’avvenire; ma soltanto la cono-
64
Fronto ad M. Anton. de orationibus 4 (II, p. 104 Haines) primum illud in isto genere dicendi vitium
turpissimum, quod eandem sententiam milliens alio atque alio amictu indutam referunt.
65
Cfr. Newman (1989, p. 1475; 1478; 1488-1489; 1494), che tuttavia non pone una netta distinzione tra
admonitio e meditatio. Un quadro chiaro e convincente dei legami che uniscono la meditatio alla retorica è
tracciato da Armisen-Marchetti (2004-2005).
66
Newman (1989, p. 1488). Cfr. p. 1484 («the heart and soul of the ethical life»), sebbene qui Newman
aggiunga un’importante sfumatura («the only means by which the parenetic part of philosophy can be
effective»: il corsivo è mio).
67 Come già abbiamo osservato in riferimento alle Consolazioni.
68 Cfr. epist. 123,3 debemus exerceri ne haec timeamus, ne illa cupiamus.
69 Cfr. la vivace descrizione in epist. 56.
70 Per es. tranq. an. 17,3; ma più comunemente Seneca predica l’isolamento dalla folla, la cui influenza può
facilmente vanificare il progresso del proficiens.
71 Cfr. epist. 16,1 e 6 rispettivamente.
72 Traina (1974, pp. 9-23). Tra gli studi successivi va menzionato Lotito (2001).
73 Foucault (1988, pp. 53-54).
74 Cfr. Edwards (1997).
75 De ira 3,36; epist. 83,2. La pratica ebbe origine nel pitagorismo: cfr. Cic. sen. 38; almeno a partire da un
determinato momento non ebbe lo scopo di esercitare la memoria (come sostenuto da Inwood [2005, p. 343]),
ma di migliorare il proprio io: cfr. carm. aur. 40-44; Hierocl. in carm. aur. 19, pp. 79-84 Koehler.
76
Epist. 16,2; 28,10; 68,6.