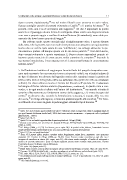Page 23 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 23
La filosofia come terapia, autotrasformazione e stile di vita in Seneca 11
88
stesso osserva ripetutamente; ma nel nostro filosofo esso conserva un serio valore.
90
89
Seneca consiglia esercizi di povertà volontaria a Lucilio e li pratica lui stesso. La
91
povertà, certo, non è in sé necessaria alla saggezza; ciò che è importante in questo
esercizio è il passaggio da una forma di contingente difesa contro una disgrazia temuta
a un vero e proprio saggio e verifica di autosufficienza (di autarkeia), come dote per-
92
manente che dovrà essere propria del saggio.
Ma sebbene anche questo esercizio miri al miglioramento etico, è ancora distante
dalla meta. Che la povertà non è un male viene provato non attraverso un ragionamento
teorico che ne sveli la reale natura di cosa ‘indifferente’, ma soltanto attraverso la spe-
93
rimentazione pratica. «È dunque questo ciò di cui avevo paura?». Così dirà Lucilio,
dopo essersi sottoposto a questa esperienza. E Seneca stesso apprenderà proprio at-
94
traverso questo esercizio di avere ancora molto cammino da compiere. Secondo la
sua stessa formulazione, il suo impetus non si è ancora trasformato in un permanente
95
habitus animi.
5. Nell’ambizioso tentativo di raggiungere la meta finale del progetto terapeutico sene-
cano sarà necessario far nuovamente ricorso a strumenti verbali; ma si tratterà adesso di
un tipo di discorso ben diverso dall’appello retorico alle emozioni messo in pratica da
Seneca nella teoria e nella pratica della sua admonitio etica (oltre che nella sua meditatio
verbale). Un chiaro abbozzo teorico è fornito dal filosofo nell’epistola 38. L’admonitio
ha bisogno di forme retorico-oratorie (disputationes, contiones), in quanto mira a con-
96
vertire, o in ogni modo a influire sull’animo del destinatario; ma quando si tratta di
istruirlo effettivamente sui fondamenti teorici della saggezza, c’è invece bisogno del
97
sermo, un discorso che, secondo la formulazione senecana, si occupa delle res, non
99
98
dei verba, si rivolge alla ragione, e rinuncia a qualsiasi appello alle emozioni. Per Sene-
100
ca il filosofo deve essere in grado di padroneggiare entrambi i tipi di discorso.
88
Epist. 18,7 non est nunc quod existimes me dicere Timoneas cenas et pauperum cellas et quidquid aliud est
per quod luxuria divitiarum taedio ludit; 100.6 desit sane varietas marmorum… et pauperis cella et quidquid
aliud luxuria… miscet.
89
Epist. 18,5; 20,13.
90
Epist. 87. Per un’analisi approfondita di questa epistola vd. Allegri (2004).
91
Seneca è uno stoico, non un cinico: cfr. Scarpat (1975, pp. 92-93); Goulet-Cazé (1986, pp. 185-186); Rist
(1989, p. 1994).
92
Cfr. Allegri (2004, p. 19; 25). Per Seneca, per es. epist. 20,8. A questo livello, tuttavia, l’autarkeia è ancora
semplicemente tentata sperimentalmente, non ancora afferrata e acquisita teoricamente.
93 Epist. 18,5 hoc est quod timebatur?
94 Epist. 87,5 parum adhuc profeci: nondum audeo frugalitatem palam ferre; etiamnunc curo opiniones
viatorum. Vd. l’analisi di Allegri (2004, pp. 34-42). Come Seneca rivolge consolazioni agli altri ma è
incapace di consolare se stesso (cfr. sopra, nota 31), allo stesso modo consiglia a Lucilio di sottoporsi a
esercizi di povertà attraverso i quali lui stesso apparirà ancora molto lontano dalla perfezione. Perfino
l’esercizio di epist. 56 finisce con un fallimento.
95 Cfr. epist. 16,6 (sopra, nota 71).
96 Simili forme oratorie sono in effetti necessarie ubi qui dubitat inpellendus est (epist. 38,1); cfr. epist. 87,41.
97 Il sermo è in effetti necessario ubi… non hoc agendum est, ut velit discere, sed ut discat (epist. 38,1).
98 Cfr. epist. 40,14; 52,14; 59,4-5; 75,5; 100,10; 108,6-7; 115,1; tranq. an. 1,13.
99 Una trattazione più ampia sull’argomento in Setaioli (2000, pp. 111-217; specialmente 116-120). Vd. anche
sopra, nota 44.
100
Cfr. Setaioli (2000, pp. 118-119).