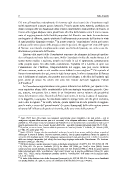Page 16 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 16
4 Aldo Setaioli
Ciò non gl’impedisce naturalmente di ricorrere agli stessi topoi che s’incontrano negli
scritti appartenenti a questo genere letterario. Proprio questo testo, tuttavia, costituisce un
chiaro esempio dell’uso funzionale della retorica caratteristico della scrittura di Seneca. Il
ricorso allo ǝǡ˛ǖNj ǚǕdžǍǓǙǗ viene giustificato alla fine della lettera come il mezzo neces-
sario al raggiungimento della finalità propostasi dal filosofo: non tanto la consolazione
contingente ed effimera, quanto piuttosto il rafforzamento permanente dell’anima in vista
29
di ogni possibile disgrazia avvenire. In questo senso la ‘consolazione’ stoica può essere
collocata sullo stesso piano della terapia contro le passioni che appare nel resto dell’opera
di Seneca: non intende semplicemente curare una ferita del passato, ma mira a una tra-
sformazione permanente dell’anima.
Esistono altri aspetti delle Consolazioni senecane che ritornano in forma più profon-
da e sviluppata nel resto della sua opera. Nella Consolatio rivolta alla madre Seneca è al
tempo stesso medico e paziente, proprio nel modo in cui si rappresenta costantemente
nella propria opera. Un altro testo consolatorio, l’epistola 63 a Lucilio, si apre con
l’ammissione che l’ȡǚdžǒǏǓNj, l’imperturbabilità del saggio, non può essere richiesta
30
all’uomo comune, anche se ciò sarebbe senza dubbio la cosa migliore. Ciò equivale al
franco riconoscimento che qui, come in tutta la sua opera, lo sforzo terapeutico di Seneca
non è indirizzato al sapiente, che peraltro non ne ha bisogno; e alla fine dell’epistola egli
pone anche se stesso fra coloro che sono ben lontani dall’aver raggiunto l’ideale
31
dell’ȡǚdžǒǏǓNj.
Le Consolazioni appartenevano a un genere letterario ben definito, per quanto in Se-
neca acquistino alcune delle caratteristiche della sua strategia terapeutica generale. Que-
sta, tuttavia, non poteva fare a meno di un fondamento teorico relativo alla possibilità
stessa del progresso etico. Secondo gli Stoici ogni uomo, in teoria, è capace di raggiunge-
re la saggezza, o sapientia. La sua stessa natura lo spinge verso ciò che gli si conviene,
32
vale a dire la ragione. In realtà, tuttavia, questa spinta ben di rado permette di raggiun-
gere la meta, a causa del ‘pervertimento’ (in greco ǎǓNjǝǞǛǙǠʎ) della retta ragione umana
33
ad opera dell’influenza di quanto ci circonda, delle cose come delle persone.
29
Epist. 99,32 haec tibi scripsi, non tamquam expectaturus esses remedium a me tam serum…, sed ut
castigarem exiguam illam moram qua a te recessisti, et in reliquum adhortarer contra fortunam tolleres
animum etc. Allo stesso modo, la Consolatio ad Helviam mira non semplicemente a consolare la madre per il
proprio personale esilio, ma a vincere la paura dell’esilio – una delle sventure più temute (epist. 85,41; 91,8).
30
In pratica, se non in teoria, Seneca adotta la posizione di Crantore (Crantor F 3a Mette; cfr. Setaioli [1999,
p. 147]). Cfr. anche epist. 99,5.
31 Epist. 63,14-16. Seneca, che sta consolando Lucilio per la morte di un amico, cadde lui stesso in preda al
dolore per la morte di Sereno. Occorre osservare, tuttavia, che da questa esperienza Seneca ha appreso la
necessità della meditatio (epist. 63,14 numquam cogitaveram mori eum ante me posse): si tratta di un pilastro
della sua strategia terapeutica (vd. oltre), che trova largo impiego anche nelle Consolazioni. Cfr. Armisen-
Marchetti (1986, pp. 188-189).
32 Gli Stoici davano a questo processo il nome di ǙɍǔǏʐǣǝǓǜ (conciliatio): cfr SVF I 181; 197; II 724; III 178-
179; 229a; 492. Cfr. per es. Pembroke (1971); da ultimo Gill (2006, pp. 36-46) e Bees (2004). Seneca
conosceva bene questa dottrina, da lui discussa in epist. 121 (cfr. Setaioli, [1988, p. 306]). In questa epistola
tratta principalmente della ‘conciliazione’ degli esseri viventi con la propria costituzione fisica (cfr. anche
epist. 14,1; 116,3); ma ha chiaramente presente anche la ‘conciliazione’ dell’uomo con la ragione (epist.
121,3; cfr. 104,23).
33 Si tratta della dottrina stoica della ǎǓNjǝǞǛǙǠʎ (perversio): cfr. SVF III 228-236. Seneca aveva familiarità
con questa dottrina: cfr. epist. 95,52-58, col commento di Bellincioni (1979, pp. 194-201).