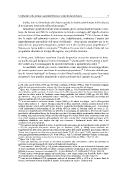Page 19 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 19
La filosofia come terapia, autotrasformazione e stile di vita in Seneca 7
Inoltre, non va dimenticato che Seneca accetta la dottrina posidoniana dell’esistenza
49
di un elemento irrazionale nella psiche umana.
Nonostante questi precedenti nello stoicismo greco, alcuni studiosi tendono a rite-
nere che Seneca sacrifichi la comprensione razionale a vantaggio dell’appello emotivo
50
nel suo sforzo di fare accettare lo stoicismo ai propri destinatari. Ciò è dovuto al fatto
che lo stadio dell’admonitio retorica – che, indubbiamente, costituisce l’aspetto più
immediatamente percepibile dell’opera del filosofo – viene spesso scambiato per la to-
51
talità del suo programma terapeutico, mentre non è che il primo passo propedeutico.
52
Seneca non lascia dubbi in proposito. Vedremo fra poco che lo stadio finale del suo
programma educativo si rivolge alla ragione, non più alle emozioni.
4. Prima, però, dobbiamo esaminare il grado terapeutico successivo proposto da Sene-
53
ca: quello che egli designa col nome di meditatio. Questo grado ricorre ancora a tecni-
54
che verbali, ma è accompagnato da esercizi totalmente o parzialmente pratici.
La meditatio verbale può essere considerata come una forma di autosuggestione,
55
gli esercizi pratici come una forma di ascetismo preparatorio. È divenuto abituale par-
lare di ‘esercizi spirituali’ in Seneca e in altri filosofi antichi, ma può essere fuorviante
56
accostare le loro pratiche terapeutiche a quelle predicate da S. Ignazio di Loyola.
p. 27), sulla scia di Griffin, (1976, pp. 350-352) e sostenuto da Wacht (1998, p. 528). Il frammento crisippeo
citato alla nota precedente sembra indicare che l’idea non possa essere scartata alla leggera.
49 Epist. 92,1. Posidonio è citato in 92,10. Cfr. Setaioli (2000, p. 141). Naturalmente l’elemento irrazionale
deve obbedire a quello razionale. Ai nostri scopi non fa differenza ammettere che l’inizio della lettera derivi
anch’esso in ultima analisi da Posidonio, come ritengo probabile (vd. Setaioli [1988, pp. 304-305; 2000,
pp. 298-299 n. 126], con la bibliografia citata e discussa), o che l’influenza posidoniana sia limitata alla
citazione esplicita del § 10, come sostenuto da altri.
50 Ciò avviene anche in un lavoro recente: Cooper (2006), p. 47: «there is a danger – and I will argue that
Seneca falls victim to it – that in relying so heavily on these rhetorical, emotion-evoking devices of the
spiritual director, a Stoic writer will tend to forget or neglect the fact that the ultimate goal… is to achieve
a full philosophical understanding of the reasons why the truths of Stoicism really are true»; p. 55:
«Seneca so completely cuts off the basis on which he is encouraging his addressee to live from the reasons
provided by philosophical theory for living that way, that it becomes highly questionable whether they can
be making real progress toward virtue and the fully happy life if they follow him». Newman (1989) cade
in un errore analogo a proposito della meditatio. Vd. oltre, nota 66. Ma l’evidente fastidio senecano per le
sottigliezze dialettiche non implica che egli non riconosca i fondamenti teorici delle idee e dei
comportamenti da lui predicati.
51
Un equivoco analogo riguarda il ruolo e la posizione dei praecepta e dei decreta (discussi nelle epistole 94
e 95) nel programma terapeutico. Alcuni (per es. Newman, [1989, p. 1484]) hanno sostenuto che
l’apprendimento della teoria generale (decreta) precede quello delle regole specifiche (praecepta). Sebbene
Seneca non si esprima con chiarezza su questo punto (epist. 95,38, 54 vs. epist. 95,64), sappiamo però che i
praecepta generalmente precedevano (cfr. Dihle [1962, p. 92]). Lo stile dell’admonitio è adatto ai praecepta,
mentre i decreta richiedono un tipo diverso di discorso, il sermo (Setaioli, 2000, p. 118). Vd. oltre.
52 Epist. 33,6-7; 38,1; 94,43.
53 Come già osservato, ciò avviene in uno stadio successivo alla ‘conversione’: coloro che praticano la
meditatio si sono già impegnati nel tentativo di migliorarsi moralmente.
54 Come osserva P. Hadot (1981, p. 14), questo comportamento è «l’œuvre non seulement de la pensée, mais
de tout le psychisme de l’individu». Il termine senecano meditatio corrisponde al greco ǖǏǕʌǞǑ; non di rado è
abbinato a exercere / exerceri / exercitatio (cfr… il greco ȥǝǔǑǝǓǜ). Cfr. Bellincioni (1979, pp. 184-185).
55 Questi esercizi costituiscono appunto un’esercitazione, e non vanno confusi con il modello finale e ideale
di comportamento, cui si giunge soltanto al termine del processo terapeutico. Vd. oltre, nota 103.
56 Come ha fatto Rabbow (1954), giustamente criticato da Newman (1989, p. 1476 n. 6). La meta finale di
Seneca è ovviamente diversa da quella di Ignazio. Per la pratica vd. anche I. Hadot (1969).