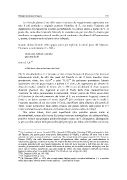Page 145 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 145
Virgilio in Seneca tragico 133
Lo Hercules furens è una delle opere in poesia che maggiormente rappresenta non
solo il più profondo e originale pensiero filosofico di S., ma anche l’esempio più
significativo del rapporto tra il nostro poeta/filosofo e la cultura antica, a partire da V., il
poeta che, come dice Giancarlo Mazzoli, S. considera un, per non dire il, classico per
eccellenza: un rapporto prima di ascolto, poi di confronto e da ultimo di differenziazione
e, spesso, di superamento sul piano etico-culturale.
Quanto stiamo dicendo credo appaia ancor più esplicito in alcuni passi del Thyestes.
Proviamo a confrontarne il v. 560 s.
otium tanto subitum e tumultu
quis deus fecit?
37
con ecl. 1,6:
o Meliboee, deus nobis haec otia fecit.
Che S. stia alludendo a V. è provato, se mai ci fosse bisogno di prova per due loci così
vistosamente simili, da altri due passi del filosofo in cui il verso bucolico viene
38
39
apertamente citato: ben. 4,6,4 e epist. 73,10. Ne parleremo prestissimo. Intanto
osserviamo che nel passo tragico a parlare è il Coro, che rappresenta gli abitanti di
Argo (in realtà i cittadini di Roma: cfr. v. 396 in cui gli abitanti di Argo vengono
chiamati Quirites) che, ingannati al pari di Tieste dalla finta riappacificazione
‘costruita’ da Atreo, pronunciano le memorabili, ‘rituali’ parole che Titiro aveva detto
di Ottaviano (e che nella memoria dei lettori di S. era ovviamente Augusto): siamo di
40
fronte a un tipico esempio di ironia tragica (gli ascoltatori sanno che la realtà è
l’opposto speculare di ciò che recita il Coro), amplificato dalla allusione alle parole di
Titiro. Come interpretare tanta enfasi, ironica, per giunta caricata sulle parole di V.?
Come commentare una allusione a Ottaviano di una azione sadica di Atreo?
Una prima lettura, direi però superficiale (che potrebbe piacere molto ai
decostruttivisti, sempre alla ricerca di pericopi senecane antivirgiliane e/o antimperialiste),
potrebbe vedervi una polemica politico/ideologica contro un V. filoaugusteo, filoimperiale
e, per così dire, cultore della personalità (del princeps): una lettura che farebbe avvicinare,
37 Per il confronto vd. per es. Tarrant (1985) e Giancotti (1988) ad loc. Marchesi (1908), analizzando le fonti
del Thyestes, cita questo passo come prova della presenza di Virgilio, e afferma: «Il terzo Coro è tutto
intessuto di motivi comuni descrittivi e morali» (p. 91), esemplificati nelle pagine seguenti. Cfr. Picone in
Petrone (1987), che nella discussione seguita all’esposizione della studiosa, pur condividendone le
osservazioni, aggiunge: «tuttavia a me pare che Virgilio sia stato utilizzato da Seneca, oltre che per esplicitare
un aspetto particolare del suo mondo drammatico (si tratti del locus horridus o dell’Ade), per dar voce,
secondo gli sperimentati moduli formali della memoria poetica, ad una sottile polemica ideologica, cosa che
non a caso si verifica, secondo me, nei canti corali» (p. 142) e cita come esempi il confronto tra il passo
tragico in esame ed ecl. 1,6 e quello tra Med. 373-374 ed ecl. 1,61 ss. (pp. 141-142).
38 Cfr. Doppioni (1939, pp. 149-150).
39 Cfr. Doppioni (1939, p. 151).
40 Cfr. Schiesaro (2003, p. 167): «the second stanza displays again a sceptical inclination […] a question
which has a rather obvious answer for the audience – lends itself to irony».