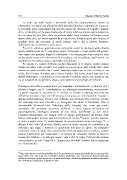Page 150 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 150
138 Giuseppe Gilberto Biondi
Le quali, pur nella vastità e profondità della loro rappresentazione umana ed
esistenziale, non vanno mai alla deriva della paternità filosofica e culturale che le genera.
E così anche Enea, il paradigma dell’eroicità romana che, allotropo di Augusto e insieme
di V., si identifica con la stessa fondazione di Roma e del suo impero spazio-temporale,
dei suoi iura, dei suoi fines, della sua eternità, anche Enea, fondatore dell’impero viene
spesso alluso da S. per essere superato da un nuovo eroe, fondatore di un altro impero, se
possibile ancor più universale di quello romano, vale a dire il sapiens, fondatore
dell’impero etico su se stesso e sulla storia.
E così le allusioni, apparentemente polemiche contro la ideologia giulio-claudia
spesso avallata anche da V., non vanno contro il principato e il suo cantore più grande:
esse vanno oltre qualsiasi forma di costituzione e di realizzazione storico-politica della
società perché vanno non a decostruire la res publica, o le res publicae, degli uomini, ma
a costruire la res publica, unica e universale, dei sapientes.
Per questo V., cantore di Roma, sembra dissonante in S. tragico, mentre risuona
sempre accordata come seconda voce quando la voce la dà ai vinti. Perché non è nella
vittoria ma nella sconfitta che l’‘uomo’ senecano mette a prova fino in fondo la sua
virtus, fino al punto di andare senza timore incontro alla morte, perché essa non è un
malum (Astianatte), o continuare a vivere quando si vorrebbe morire, non perché la vita
sia un bonum in sé, ma perché la virtus a volte significa vivere per gli altri (Ercole).
Rimangono due ultime considerazioni per inquadrare, sinteticamente, il rapporto di S.,
filosofo e tragico, con V., considerazioni cui, altrettanto sinteticamente, accenneremo.
La prima riguarda la recezione di V. nell’età di Claudio e Nerone, recezione che
difficilmente poteva essere non all’insegna di un poeta, se non il poeta di Augusto e
dunque della fondazione, diciamo così, culturale, del principato (una recezione, si badi,
che coinvolge non solo l’Eneide e le Georgiche, ma anche le Bucoliche). Non si
intenderebbe altrimenti tutta l’ideologia della Farsalia, che, come per merito
soprattutto del compianto Emanuele Narducci, si deve leggere all’insegna del
capovolgimento, ideologico appunto (e non solo), dell’Eneide (e non solo):
l’antiprovvidenzialismo del Bellum civile si spiega perfettamente all’interno della
46
lettura antieneadica, diciamo pure antivirgiliana, di Lucano. Questo, paradossalmente,
ci aiuta a capire come S., contrariamente al giovane nipote poeta, non legge V., e
dunque il suo ‘mito’ di principe (Enea), come un ideale retorico da contrastare o da
sostituire; egli legge, e trascrive, il mito/ideale dell’Enea (e, ripeto, del principato
virgiliano) come un ideale che, quand’anche divenisse realtà storico-politica, sarebbe
sempre insufficiente (un commodum o un insieme di commoda) rispetto al supremo
bonum del cittadino e di tutti gli uomini, vale a dire la virtus. Dell’eroicità di Enea
viene proposta, in tutta l’opera di S., dunque non solo delle Fabulae, non la negazione
ma il superamento.
46 Non credo che sia un caso la probabilità che il De providentia sia oramai datato dalla critica come una delle
opere ultime di S., che in tal caso si potrebbe davvero interpretare come una presa di distanza ideologica
dall’opera del nipote, in fieri, ma già letta da molti intellettuali, che stava proclamando un antiprovvidenziali-
smo nella storia, in particolare in quella di Roma.