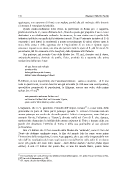Page 148 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 148
136 Giuseppe Gilberto Biondi
aggiungere, non saremmo di fronte a un malum, perché alla più malvagia delle tirannie
c’è sempre il remedium del suicidio.
Questa contro-esaltazione della storia, in particolare di Roma pre- e augustea,
predicata anche da V., viene effettuata da S., filosofo e poeta, per preparare il suo o i suoi
destinatari a un ribaltamento culturale: la sicurezza, la vera civitas non è quella delle
istituzioni politiche ma quella delle istituzioni morali. Di qui l’estenuato tentativo di S. di
convertire i suoi lettori (e ascoltatori) a questo rovesciamento di valori: abitare entro le
mura della virtus e della sapientia che è l’equivalente di un noto e ripetuto topos
senecano: regnare su se stessi, una idea che percorre tutte le opere di S., dal De ira al De
providentia, dal De clementia al De beneficiis, dalle Epistulae alle Fabulae.
Una pericope, nel secondo Coro della Medea (vv. 371 ss.), descrive così il chaos,
antropico/ecumenico, derivato da quello, fisico, prodotto da e seguente alla prima
navigazione della nave Argo:
nil qua fuerat sede reliquit
pervius orbis:
Indus gelidum potat Araxen,
Albin Persae Rhenumque bibunt
È difficile, se non impossibile, che l’ascoltatore/lettore – antico e moderno – di S. non
veda in questi versi, in cui si descrive una già avvenuta (v. 634 nunc iam cessit pontus),
apocalittica promiscuità di popolazioni, la filigrana, ancora una volta, della prima
42
egloga (vv. 61 ss.)
ante pererratis amborum finibus exul
aut Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim,
quam nostro illius labatur pectore vultus.
43
L’adynaton, che in V. garantisce l’eternità dell’impero romano e, a sua volta, della
gratitudine da parte di Titiro per il princeps (quando V. scriveva Ottaviano non era
ancora princeps ma credo che da molto presto i lettori vi scorgessero, come farà per
esempio Servio, l’allusione a ‘Cesare’), diventa realtà nel Coro di S. che, dunque,
sembrerebbe denunciare la labilità dello stesso adynaton di Titiro e dunque delle sue
parole che decantano l’eternità di Roma e della sua gratitudine al suo giovane
politico/deus.
Non c’è dubbio che il Coro secondo della Medea stia ‘cantando’, come il Coro del
Tieste che abbiamo analizzato sopra, la fine del mondo (che ha come causa prima
l’invenzione della navigazione, la nave Argo appunto, che a sua volta è responsabile non
solo dell’ira vendicativa del mare sugli uomini ma dell’arrivo nella polis di un danno
ancor più grande del mare irato: maius… mari Medea malum / merces prima digna
carina). E non c’è dubbio che questa fine, se non del mondo fisico, quanto meno
42 Per il confronto vd. Costa (1973), Hine (2000) e Németi (2003) ad loc. Cfr. anche Picone in Petrone (1986-
1987, in sede di discussione, p. 142).
43
Cfr. Heyne che cito da Forbiger ad loc.