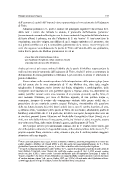Page 149 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 149
Virgilio in Seneca tragico 137
dell’ecumene (e quindi dell’impero) viene rappresentata col rovesciamento dell’adynaton
di Titiro.
Allusione polemica a V., poeta e cantore del principato augusteo? Che il brano di S.
abbia tutti i crismi che richiede lo statuto, il protocollo dell’allusione ‘polemica’
(rovesciamento semantico/ideologico con lo stesso materiale linguistico/stilistico/retorico
del testo alluso) è palmare; ma che l’allusione di S. sia ‘contro’ V. tout-court (con la
conclusione, non dico volgata, ma diffusa di un S. tragico antitetico a S. prosatore, che
mai polemizzerebbe con V.) è contraddetto palesemente da V. stesso. Dove? Proprio nei
versi che seguono immediatamente le parole di Titiro sull’eternità della sua gratitudine,
vale a dire le parole che Melibeo pronuncia ai vv. 64 ss.
at nos hinc alii sitientis ibimus Afros,
pars Scythiam et rapidum cretae veniemus Oaxen
et penitus toto divisos orbe Britannos.
Anche qui non ci può essere ombra di dubbio che le parole di Melibeo rappresentano la
realizzazione spazio-temporale dell’adynaton di Titiro, sicché il primo a contrastare la
dichiarazione di eterna gratitudine a Ottaviano è, per così dire, lo stesso V. attraverso le
parole di Melibeo.
Senza entrare nella vessata questione della interpretazione della prima egloga (sono
più del parere che la voce esistenziale di V. sia Melibeo che, oltre tutto, meglio
spiegherebbe il sintagma audax iuventa del finale, sfragistico e autobiografico, delle
Georgiche: dove iuventa non solo parrebbe opporsi a Tityrus, senex, ma, dipendente da
audax, potrebbe suonare come una excusatio di un peccato giovanile, quello, forse, di
aver accusato Ottaviano, per voce di Melibeo appunto, di una politica iniqua o,
comunque, incapace di ovviare alle conseguenze violente delle guerre civili) che, a
prescindere da una eventuale corretta esegesi filologica, rimanderebbe alla questione
della sua lettura da parte dei primi lettori antichi (non a caso S. sembra ricordare, di essa,
e, abbiamo visto, ‘contestare’ più le parole di Titiro che non lodare, alludendovi, quelle di
Melibeo), resta il fatto che V. è il poeta che, in tutte le sue opere, ha saputo dare voce sia
ai vincitori, presenti (come Ottaviano nel finale delle Georgiche) e futuri (Enea), sia ai
vinti, non solo dalla violenza di una guerra, civile, tra Troiani e Latini, ma anche, ancora
44
una volta come Enea, dalla madre di tutte le guerre, quella appunto di Troia.
Ed è proprio all’eroe per antonomasia romano, che in V. sembra essere frutto, più
45
che della politica culturale di Augusto/Mecenate, della cultura politica dello stesso V., è
proprio a questo Enea, vincitore e vinto, virtuoso e pio, che S. sembra prestare maggiore
attenzione nelle sue tragedie.
44 Non a caso sarà proprio Enea exul a rivivere il dramma di Melibeo, ancorché protagonista di un futuro che
sembra sfuggire a Melibeo: cfr. Biondi (2005, p. 63). Ma quello del rapporto/identificazione tra V. e Titiro
e/o Melibeo è quaestio infinita: cfr., per es., le voci Titiro e Melibeo nella Enciclopedia Virgiliana.
45 Di qui le oscillazioni interpretative sulla ‘politica’ di V., oggetto di alterazioni esegetiche da parte anche di
bravi studiosi di Harvard, come Thomas che confronta condere saecla di Lucr. 3,1090 vivendo condere
saecla con Aen. 6,792 s. aurea condet / saecula attribuendo però all’espressione lucreziana il valore di
‘deporre, seppellire’ che invece il testo didascalico non supporta affatto: condere saecla in Lucrezio ha valore
di ‘mettere insieme, stipare’ (cfr., per es., Bailey, 1947, pp. 1174 s.). Si noti anche che il Qudratus ad Lucr.
3,1090 legge ducere in luogo di condere, lezione da intendersi forse come glossa.