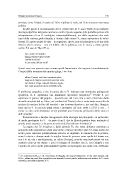Page 147 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 147
Virgilio in Seneca tragico 135
principe, come l’otium, il quale nel Titiro virgiliano è reale, nel Coro senecano menzogna
politica.
In altre parole il rovesciamento che S. sembra fare di V. non è frutto di un contrasto
ideologico/politico del poeta neroniano contro il poeta augusteo (che potrebbe portare alla
interpretazione di un S. nostalgico veterorepubblicano), ma della negazione che certi
topoi della retorica giulio-claudia, a iniziare dallo stesso V., siano espressione di valori
(bona). Da questo punto di vista – la negazione, ripeto, non del principato in sé ma della
retorica che lo ornava – non c’è dubbio che la polemica con V. suoni, a volte, apertis
verbis. È il caso di Thy. 875 ss.
nos e tanto visi populo
digni, premeret quos everso
cardine mundus?
In nos aetas ultima venit?
Questi versi non possono non evocare quelli famosissimi che seguono immediatamente
l’incipit della monumentale quarta egloga, i vv. 4 ss.
ultima Cymaei venit iam carminis aetas;
magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.
Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna,
iam nova progenies caelo demittitur alto.
Il problema, esegetico, è che le parole che in V. indicano una imminente palingenesi
41
(positiva), in S. esprimono una imminente apocalisse (negativa). Perché S. per
esprimere il panico del popolo – ipostatizzato dal Coro che è stato informato delle
atrocità compiute dal re, Atreo, nei confronti di Tieste (e che si sente tanto sconvolto da
credere di meritare la fine del mondo) – usa la stessa identica e, per così dire, liturgica
frase che in V. (e nei suoi primi lettori e interpreti: cfr. Hor. serm. 1,5,103 s. nec … /
tristis ex alto caeli demittitur tecto) promette una rinnovata primavera della storia e
dell’umanità?
Rovesciamento e dunque rinnegamento della ideologia del principato – in particolare
di quella proclamata da V. – da parte di un S. che da filosofo predica bene, esaltando il
grande poeta augusteo, e da poeta razzola male (facendosene detrattore)?
Le pagine del De beneficiis e della epistola 73, che sopra abbiamo esaminato a
proposito della espressione otium deus dedit, ci fanno intendere qual è il senso anche del
nostro passo senecano polemicamente allusivo al virgiliano: la denuncia che la politica,
come la storia, e dunque anche la miglior forma di governo come quella del bonus rex,
non è in sé, mai e assolutamente, un valore (bonum), potendo essa trasformarsi nel suo
contrario (con un rex malus: e non c’è bisogno di ricordare che S., con Caligola e con
Claudio, ne aveva anche personalmente esperito la malvagità): ma anche così, dobbiamo
41 Cfr. Schiesaro (2003, p. 173). Osserviamo, di sfuggita, che Iacopus Baldus (sec. XVII), Liber Epodon, Ode
20,1 s., ultima iam venit fatis argentibus aetas riprende le stesse parole, nella stessa sede metrica, di V. con la
semantica, apocalittica appunto, di S.