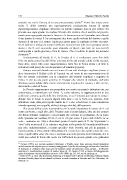Page 140 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 140
128 Giuseppe Gilberto Biondi
21
renitente ma con la fierezza di un eroe precocemente adulto. Vorrei fare notare come
anche S. abbia costruito una rappresentazione poeticamente intensa di questa
ripresa/opposizione virgiliana: attraverso un potente ossimoro (non si può trahere chi
procede non segni gradu: ma trahens rimanda alla violenza che si esercita sul piccolo,
mentre non segni gradu esprime la fierezza e la fermezza con cui il parvulus eroe affronta
il suo destino di morte) S. ha contrapposto due forze: quella violenta del destino e quella
virtuosa di chi non vi si sottrae. Anche per questo passo il confronto va fatto con epist.
82,12 laddove si denigra la morte di (Decimo Giunio) Bruto (che cercò periturus mortis
moras e che S. così commenta: quae dementia est fugere cum retro ire non possis!)
contrapposta a quella gloriosa e fiera di Catone. Che è modello di quella del parvulus
22
Astianatte.
Contrariamente all’Eneide di V., le Troades di S. si configurano come fine della
Urbs ma anche come fine dell’Orbis: una sorta di fine del mondo e della civiltà che può,
forse deve, essere letta come rappresentazione della fine di Roma stessa e di tutte le
istituzioni civili (iura) che essa ha garantito all’umanità (populos).
Dunque una anti-Eneide non nel senso di una anti-ideologia virgiliana (come si
deve interpretare il Bellum civile di Lucano) ma nel senso di una rappresentazione di
fine del mondo coincidente con la negazione dell’eternità virgiliana e augustea di
Roma. Il che da una parte avvicina le Troades alla visione di Sallustio, dall’altra
allontana questa fabula dalla visione storicamente negativa che Lucano, e altri con lui,
stava dando o darà di Roma.
Le Troades rappresentano una prospettiva non contro ma senza le istituzioni che, per
antonomasia, si identificano con Roma. È, come vedremo, la rappresentazione di una
condizione estrema, quella della fine imminente, in cui l’umanità può salvare la virtus e
dunque fino in fondo la propria dignità sulla base e con la forza non, appunto, delle
istituzioni, civili, della polis (quelle cantate da V. e che, si badi bene, S. non contesta ma
intende superare), ma su quelle, etiche (e dunque stoiche), della persona.
Che questa debba essere la prospettiva con la quale interpretare le riprese da V. nel
nostro confronto, e negli altri, delle Troades credo si possa dedurre, oltre che dai contesti
che finora abbiamo comparato e dai prossimi che vedremo tra pochissimo, da un passo
delle Epistulae ad Lucilium, 82,18, in cui S. cita per esteso il passo della Sibilla: tu ne
cede… audentior ito. Oltre a dimostrare quanto il nostro passo di V. sia ‘importante’ e
‘vivo’ nella memoria di S., la citazione virgiliana nella epistola 82 rimanda mirabilmente
non solo, antifrasticamente, al passo specifico delle Troades, ma più in generale, e
sintonicamente, al tema centrale della fabula che si articola su due aspetti sostanziali: uno,
etico, è quello della virtus che vince e permette una morte gloriosa (così Astianatte, che in
realtà non cederà di fronte alla morte ma l’affronterà da piccolo grande eroe gettandosi
21 Corsaro (1991), pur tacendo qualsiasi riferimento a Virgilio come fonte senecana (bensì limitandosi
esclusivamente alla tragedia greca e romana), tratteggiando il profilo del personaggio afferma che il sacrificio
di Astianatte si configura come «una sorta di “passione epica” di ispirazione stoica, pregna… di libertarie
aspirazioni e manifestazioni, seppure di matrice laica» (p. 71). Mader (1997) a riprova dell’atteggiamento
eroico di Astianatte cita la similitudine epica (vv. 1093-1098): pp. 343-344, ma cfr. anche pp. ss.
22 Mader (1997, p. 345): «the spectacular death-leap of Astyanax and Polyxena’s unflinching fortitude display
the same Stoically tinged virtus admired by Seneca in such exemplars as Hercules and Cato Uticensis»; cfr.
anche pp. ss.