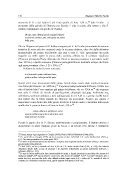Page 142 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 142
130 Giuseppe Gilberto Biondi
26
memoria di S. e dei lettori è più forte quello di Aen. 1,46 ss. (che Ovidio – a
proposito della gelosia di Giunone per Semele – cita, in parte, alla lettera e che S.
sembra contaminare con quello di Ovidio):
ast ego, quae divum incedo regina Iovisque
et soror et coniunx, una cum gente tot annos
bella gero.
Che in filigrana nel passo di S. debba scorgersi più V. di Ovidio (nonostante la comune
tematica di soror più che coniunx) credo lo si possa dedurre, oltre che dalla altissima
memorabilità del primo dell’Eneide, che non a caso S. ‘cita’ spessissimo sia nelle
tragedie sia nelle opere in prosa dalla assoluta affinità tra il contesto virgiliano
(Giunone perseguita Enea, destinato da Giove ai moenia promissa e ad sidera caeli:
Aen. 258 ss.) e quello senecano (Giunone perseguita Ercole destinato sempre da Giove
27
agli astra promissa: Herc. f. 23 e 958 s.).
Vediamo da vicino il passo senecano:
in alta mundi spatia sublimis ferar,
petatur aether: astra promittit pater.
Questi versi sono pronunciati dallo stesso Ercole dopo essere stato improvvisamente
28
reso folle (da Giunone: vv. 939b ss.). L’apoteosi autoproclamata di Ercole è frutto non
29
solo di hybris (che l’eroe esprime già prima del fulmen: cfr. vv. 926b ss. che seguono
non solo il rifiuto di Ercole di purificazione chiestogli dal pius Anfitrione ma,
addirittura, sembrano alludere a temi palingenetici di ecl. 4,24 ss. e georg. 2,538) ma di
una hybris che la follia causata da Giunone sta accecando. Proprio per questo è
inquietante come dietro alle folli parole di Ercole il lettore antico e moderno intravveda
30
quelle che V. pone in bocca a Giove in Aen.1,258 ss.
cernes urbem et promissa Lavini
moenia sublimemque feres ad sidera caeli
magnanimum Aenean.
Perché le parole che in V. dicono, positivamente e propriamente, il destino storico e
ultraterreno di Enea vengono poste in bocca a un Ercole reso furens e oltremodo
26 Il locus similis è già segnalato in Caviglia (1979), Fitch (1987) e Billerbeck (1999) ad loc.
27 Per quest’ultimo Caviglia (1979, ad loc.) rimanda ad Aen. 1,259-260. Cfr. anche Motto-Clark (1981, p.
111). Per astra promittere cfr. anche epist. 48,11.
28 Il rifiuto di purificarsi prima del sacrificio e la hybris sono segnalati anche da Putnam (1992, p. 247) come
sintomi della follia di Ercole.
29 Fitch (1987, ad loc.) rimanda ad Aen. 8,325 ss. Cfr. anche Motto-Clark (1981, p. 109), che tuttavia
difendono Ercole dalle accuse di impietas e di superbia richiamando la natura semidivina dell’eroe, e
Schiesaro (2003, p. 185).
30 Se mai ci fossero dubbi sulla forte intertestualità dei passi, a fugarli interviene la macchina che, mentre del
sintagma sublim* fer* riporta diverse occorrenze, alla ricerca di sublim* + fer* + promi* rintraccia solo i
nostri due loci; per non dire delle altre affinità verbali come astra di S. e sidera di V., nonché di tutto il
contesto che rimanda al medesimo tema, quello appunto dell’apoteosi dell’eroe.