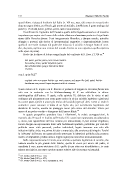Page 144 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 144
132 Giuseppe Gilberto Biondi
quest’ultimo si piega al desiderio del figlio (v. 704 nec, nate, tibi comes ire recuso) solo
dopo un segno divino, per Ercole, già pronto al suicidio, è sufficiente il gesto analogo del
padre (v. 1314 iam parce, genitor, parce, iam revoca manus).
Il confronto tra l’episodio dell’Eneide e quello della tragedia senecana è di massima
importanza per capire sia il senso della voluta allusione al maximus poeta sia il significato
stesso dello Hercules furens. Il cui insegnamento filosofico, e dunque morale, potrebbe
sfuggire e portarci alla deriva di interpretazioni soggettive e impressionistiche (come
quella di un Ercole ricattato dal padre che minaccia il suicidio e dunque frutto di un S.
che, da poeta, esprime una visione del mondo diversa se non opposta a quella espressa
nelle opere in prosa).
34
Credo che la chiave di lettura venga fornita dal confronto di S. Herc. f. 1314 ss.
iam parce, genitor, parce, iam revoca manum.
Succumbe, virtus, perfer imperium patris.
Eat ad labores hic quoque Herculeos labor:
vivamus.
35
con S. epist.78,2
cogitavi enim non quam fortiter ego mori possem, sed quam ille (scil. pater) fortiter
desiderare non posset. Itaque imperavi mihi ut viverem.
Questa lettura di S. tragico con S. filosofo ci permette di leggere lo Hercules furens non
solo non in contrasto con la Weltanschauung di S. ma addirittura in chiave
autobiografica dell’autore. Il quale, nella epistola 78, dichiara che la virtus si può
realizzare più pienamente non come gesto eroico in sé (un suicidio legittimo e glorioso)
ma come gesto (umile e ancor più eroico del suicidio) per gli altri. Come si vede in
entrambi i passi senecani si tratta di un figlio che, pur moralmente legittimato dal
desiderio di morire, accetta un passaggio ancor più eroico del suicidio: vivere per
36
amore di un padre vecchio e bisognoso dell’amore filiale.
In questa prospettiva prendono luce i riferimenti, le volute sovrapposizioni, le
memorie che l’Enea di V. declina sull’Ercole di S.: questi non rappresenta una alternativa
o, meno, una opposizione all’eroe romano per antonomasia, il pius Aeneas virgiliano;
Ercole disegna un superamento delle virtù tradizionali quiritarie, pubbliche, per così dire
politiche verso virtù personali, perfino individuali, legate insomma non solo alle
istituzioni della civitas ma, prima di tutto e sopra tutto, alla coscienza del singolo. Perché
la ‘salvezza’ dell’uomo non passa più solo attraverso le istituzioni politiche (che possono
essere, se degenerate, perfino arma a doppio taglio) ma attraverso istituzioni morali.
Nella rappresentazione di Ercole, eroe umiliato e pertanto legittimato al suicidio, che
tuttavia accetta la più grande delle fatiche, quella di vivere per amore del padre, si
manifesta il vero, nuovo stoicismo di S.: quello di una etica non trionfalistica e, in certa
misura narcisistica, ma tanto assoluta quanto relativa alle circostanze esistenziali.
34 Cfr. Motto-Clark (1981, p. 115).
35 Cfr. Motto-Clark (1981, p. 107).
36
Cfr. Motto-Clark (1981, p. 105 e soprattutto p. 107).