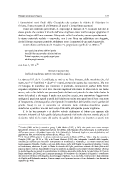Page 139 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 139
Virgilio in Seneca tragico 127
i famosissimi versi finali delle Georgiche che cantano la vittoria di Ottaviano in
Oriente, il suo processo di civilizzatore di popoli e la sua futura apoteosi.
Come nel confronto precedente, S. capovolge il discorso di V. in modo tale che le
stesse parole che cantano il trionfo dell’eroe virgiliano siano riutilizzate per epigrafare il
destino tragico dell’eroe senecano. Ma questa volta il confronto, ancora specularmente –
lo stesso materiale verbale – capovolto, non è con Enea ma addirittura con Augusto,
sicché il brano senecano potrebbe addirittura avere i connotati di una anti-Augusteide.
19
Come ultimo confronto tra le Troades e V. proponiamo quello di vv.1088 ss.
per spatia late plena sublimi gradu
incedit Ithacus parvulum dextra trahens
Priami nepotem, nec gradu segni puer
ad alta pergit moenia.
20
con Aen. 2, 723 s.
dextrae se parvus Iulus
implicuit sequiturque patrem non passibus aequis.
La ripresa di S. da V. è certificata, se mai ce ne fosse bisogno, dalla macchina che, del
nesso parv* (= bambino) + dextr* (= mano), porta solo queste due occorrenze. Ma non
c’è bisogno di macchine per rimarcare il profondo, commovente pathos della breve
sequenza virgiliana in cui si dice che Iulo implicuit alla mano di Enea non la sua mano
ma se, vale a dire tutta la sua persona (tanto da farsi così piccolo da stare tutto dentro la
mano del padre) e che segue il padre non passibus aequis, una espressione leggermente
ambigua (i passi non uguali a quelli dell’adulto ma anche non uguali tra di loro: una sorta
di fotogramma cinematografico che riprende il trotterellare del bambino tra le gambe del
grande Enea) in cui si concentra un elemento tanto realistico-descrittivo quanto
metaforico e patetico: uno dei tanti colpi d’ala della più squisita poesia virgiliana.
S. lo ha ben presente e si direbbe volerlo richiamare al lettore per opporre alla
memoria intenerita di Iulo quello del piccolo-grande Astianatte che non avendo più su di
sé (come Iulo) né la mano del padre né quella del destino va incontro a questi non
19
Keulen (2001 ad loc.) rimanda a georg. 1,404. Mader (1997, p. 345) cita questi versi come esempio
tipicamente senecano di spettacolarizzazione del delitto, individuando nella teichoscopia la combinazione
dell’eroismo epico e del pathos tragico che fa di Astianatte (e Polissena) degli eroi, «moral gladiators, not
captives but free, not victims but victors» (Pratt, 1983, p. 111).
20 Cfr. Boyle (1994 ad loc.). Lo stesso confronto è proposto da Mader (1997, p. 344, n. 62), che rimanda a
Caviglia (1981, pp. 98-99, n. 28), e da Danesi Marioni (1999) che, indagando i modelli della tragedia,
riscontra gli elementi più innovativi nell’episodio di Andromaca e Astianatte, i cui ritratti risentono della
poesia augustea (Virgilio, Ovidio e, nel caso della donna, anche dell’elegia); lo sguardo privilegiato è rivolto
ad Andromaca, attraverso il quale è filtrata la vicenda del figlio, proiezione costante di Ettore (lettura del
passo in chiave erotica). Inquadrando il locus in questione in rapporto ai precedenti letterari afferma: «Seneca
in questa tragedia non prende in considerazione lo sviluppo successivo della storia, la resurrezione di Troia in
Roma attraverso gli Eneadi, ma il mancato passaggio del testimone da Astianatte ad Ascanio è sottolineato
dai numerosi richiami, nella tragedia, al personaggio virgiliano. Se, a sua volta, Ascanio-Iulo è stato plasmato
da Virgilio sull’Astianatte omerico, Seneca compie ora il percorso inverso e il suo Astianatte è un Ascanio in
negativo» (p. 494).