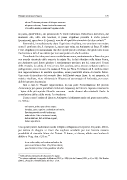Page 137 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 137
Virgilio in Seneca tragico 125
urbem Troianam primum dulcisque meorum
reliquias colerem, Priami tecta alta manerent,
et recidiva manu posuissem Pergama victis.
un passo, quest’ultimo, cui palesemente S. vuole richiamare l’attenzione del lettore, dal
momento che, oltre alla iunctura, il passo virgiliano presenta il verbo ponere
13
(posuissem), speculare a S. (ponas), nonché alla perfetta simmetria dei due contesti.
Sennonché, immediatamente dopo l’agnizione virgiliana, non possiamo non notare
come il confronto che S. ripropone è, ancora una volta, tra Astianatte ed Enea. È infatti
l’eroe virgiliano per antonomasia che dice quelle parole a Didone, che grida tutta la sua
frustrazione e tutto il suo dolore per non aver potuto ciò che ha voluto.
Il confronto fra i due passi serve a sottolineare come, contrariamente a Enea che, pur
non avendo ricostruito dalle macerie la caduta Ilio, la farà rifondare nella futura Roma,
per Astianatte quel futuro glorioso è assolutamente precluso; per lui, come per i Teucri
delle Troades, la caduta di Troia è una fine assoluta, senza nessun eschaton soterico o
palingenetico, come invece è la caduta di Troia per Enea. Il richiamo di S. sembra essere
una rappresentazione di assoluta apocalisse, senza possibilità alcuna di riscatto futuro.
Una sorta di riscrittura del secondo libro dell’Eneide senza Enea: la cui memoria, di
matrice virgiliana, viene richiamata in filigrana sul personaggio di Astianatte, per essere
definitivamente decostruita.
Non a caso le Troades rappresentano, da una parte l’eroicizzazione del piccolo
Astianatte (e per questo potrebbero intitolarsi Astyanax), dall’altra la risposta consolatoria
– tipica della più squisita filosofia senecana – anche dinanzi alla catastrofe finale: la
consolazione dalla e della morte. Lo rivedremo.
E non a caso l’ombra di Enea su Astianatte è richiamata anche nel passo successivo,
vv. 507 ss.:
en intuere, turba quae simus super:
tumulus, puer, captiva: cedendum est malis.
Sanctas parentis conditi sedes age
aude subire. Fata si miseros iuvant,
habes salutem; fata si vitam negant,
habes sepulcrum.
Con queste parole Andromaca invita il figlio a rifugiarsi nel sepolcro del padre, Ettore,
per tentare di sfuggire ai Greci che vogliono ucciderlo per non lasciare nessuna
possibilità di rinascita futura dei Troiani. Il brano, si diceva, allude senz’ombra di
14
dubbio a Verg. Aen. 6,95 ss.:
tu ne cede malis, sed contra audentior ito
qua tua te fortuna sinet. Via prima salutis,
quod minime reris, Graia pandetur ab urbe.
13 Sulla estrema vicinanza dei due passi cfr. supra.
14 Lo stesso confronto è suggerito da Moricca (1918, p. 442) (cito da Corsaro [1991, p. 8, n. 43]). Cfr. Keulen
(2001), che ad loc. rimanda anche ad Aen. 11,158.