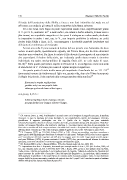Page 138 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 138
126 Giuseppe Gilberto Biondi
Si tratta dell’esortazione della Sibilla a Enea a non farsi intimidire dai mala ma ad
affrontare con audacia gli ostacoli nella prospettiva della futura salvezza.
Tra i due brani certo fanno da ponte espressioni simili come, rispettivamente prima
15
in V. poi in S., audentior ito e aude subire, via salutis e habes salutem, fortuna sinet e
fata iuvant, ma soprattutto magnetizza i due passi il sintagma ne cedere malis, declinato
in imperativo in ambo i casi, ma, in V., con imperio proibitivo (e solenne: ne cede)
rivolto dalla Sibilla a Enea, in S., con rassegnata e inevitabile passività (cedendum est)
dichiarato da Andromaca ad Astianatte.
Ancora una volta S. pone accanto al destino del suo piccolo eroe Astianatte che deve
cedere ai mala quello, specularmente opposto, del Teucro Enea, che da vinto diventerà
vincitore non cedendovi. Per Enea la caduta di Ilio diventa il presupposto di una rivincita
che capovolgerà il destino della storia, per Astianatte quello stesso evento è sinonimo
individuale ma anche storico-politico di tragedia finale (cfr. ne cede malis di epist.
16
82,18): Sotto questo particolare aspetto le Troades di S. si configurano come una sorta
di anti-Eneide di V. Vedremo più avanti di capirne meglio il significato.
17
Da questo punto di vista risulta ancor più inquietante il confronto dei vv. 771-773
(pronunciati sempre da Andromaca al figlio ma, questa volta, dopo che Ulisse ha scoperto
18
il rifugio del piccolo, il che equivale alla certezza assoluta della sua fine)
Iliaca non tu sceptra regali potens
gestabis aula, iura nec populis dabis
victasque gentes sub tuum mittes iugum,
con georg. 4,561 s.:
fulminat Euphraten bello victorque volentis
per populos dat iura viamque affectat Olympo.
15
Cfr. Petrone (1987, p. 140). Analizzando lo scenario entro cui si svolgono le tragedie senecane, la studiosa
riconosce in esso la tipologia del locus horridus, le cui caratteristiche, tipiche del paesaggio infernale,
giustificano il rapporto privilegiato con Aen. 6. Quello che in Virgilio era puro materiale
letterario/iconografico diventa in Seneca metafora del male, prestandosi dunque alla discussione filosofico-
morale: «il recupero filosofico, che motiva la citazione […] avviene spesso sul piano di una analogia, tra
Enea che va incontro all’Ade e supera indenne il contatto con i mostri e il sapiens che con tetragona fermezza
affronta dolori e timori» (p. 140). Altro esempio addotto è quello di Aen. 6,103-104 citato in epist. 76,33.
16 Cfr. Doppioni (1939, pp. 165-166), Setaioli (1965, p. 141). Alcuni commentatori virgiliani rimandano a
questo passo delle Epistulae per dimostrare il contatto tra i due autori: Forbiger (1875) trova in esso supporto
per l’emendazione del testo virgiliano ad 6,96 (ove la maggior parte dei codd. legge quam anziché qua), e
così pure Williams (1972); di parere contrario è Austin (1977) che, pur concorde nel rilevare la citazione
senecana, è convinto che anche il Cordovese leggesse erroneamente quam.
17 Cfr. Keulen (2001) ad loc. e Zissos (2008, p. 195), che rimanda anche ad Aen. 6,851-853.
18 L’espressione iura dare è frequente, ricorrendo per esempio anche in Aen. 1,293 (cfr. Keulen, 2002, ad
loc., che rimanda anche ad Aen. 5,757-758; 8,147-148, e Boyle, 1994, ad loc.), iura dabunt detto di Fides,
Vesta, Remo e Quirino nel contesto in cui si parla proprio di Augusto. Tuttavia la certezza che l’ipotesto del
passo senecano sia quello delle Georgiche è data dal materiale linguistico e, in particolare, dalla semantica
della iunctura in questione: i due passi hanno in comune anche la parola populi e victi. Se mai dovessero
sorgere dubbi, la ricerca meccanica condotta sul contesto iura da*+popul*+vict* non lascia spazio al minimo
dubbio sulla specifica ripresa virgiliana da parte di S.