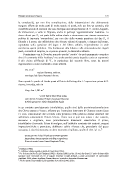Page 135 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 135
Virgilio in Seneca tragico 123
la complessità, per non dire complicazione, delle interpretazioni che ultimamente
vengono offerte da molte parti di molte scuole: si pensi, solo per fare un esempio, alla
cosiddetta scuola di Harvard che non disdegna una interpretazione di V. contra Augusto,
da rintracciarsi, a volte in filigrana, anche in pericopi ‘apparentemente’ laudative. Lo
stesso dicasi per S., cui parte della critica stenta a riconoscere una sincera concezione
politica di impronta ‘monarchica’, per non dire della vessata questione dei due S., il
filosofo e il poeta, che offrirebbero due diverse visioni del mondo, e dunque dell’uomo,
soprattutto sulla questione del logos e del libero arbitrio. Riprenderemo in sede
conclusiva questi problemi. Ora limitiamoci alla lettura e alla ermeneutica dei singoli
passi, cercando di carpirne, se ci paiono presenti, le dinamiche allusive.
Cominciamo con le Troades, non solo perché ‘servite’ da quel monumento esegetico
5
che è il commento della Fantham, ma anche perché questa tragedia canta un argomento
il più vicino all’Eneide di V., in particolare del secondo libro, tanto da potersi
rappresentare o come continuità o come alterità.
6
Tro. 16 s.
regiam flammae ambiunt
omnisque late fumat Assaraci domus.
Sono queste le parole di Ecuba quasi all’inizio della tragedia. L’espressione prima di S.
ricorre, invertita, solo in
7
Verg. Aen. 1,283 ss.
veniet lustris labentibus aetas,
cum domus Assaraci Phtiam clarasque Mycenas
servitio premet ac victis dominabitur Argis
in un contesto assolutamente trionfalistico, quello cioè della previsione/consolazione
che Giove espone a Venere, affranta per l’ennesimo intervento di Giunone contro Enea
e i suoi, consolazione che si fonda sulla promessa della gloriosa domus Assaraci che
addirittura sottometterà l’intera Grecia. Come non si può non notare i due contesti,
senecano e virgiliano, sono profondamente dissonanti: catastrofico il primo,
trionfalistico il secondo. Prima di svolgere, sull’indubbio contrasto dei contesti, esegesi
impressionistiche e premature, dobbiamo subito rilevare che, precedente del passo
8
senecano, è sicurissimamente un altro momento virgiliano, quello di Aen. 3,1 ss.,
postquam res Asiae Priamique evertere gentem
immeritam visum superis ceciditque superbum
Ilium et omnis humo fumat Neptunia Troia,
5 Fantham (1982).
6 L’edizione critica seguita è quella di Zwierlein (1986).
7 Per il locus similis cfr. già Fantham (1982) e Keulen (2001) ad loc. Si noti che dopo S. l’unico fruitore della
iunctura sarà Giovenale (3,212 si magna Assaraci cecidit domus), a parte grammatici ed epitomatori
virgiliani. Nelle glosse virgiliane Domus Assaraci equivale a Imperium Romanorum.
8
Anche questo locus similis è già segnalato da Keulen (2001) ad loc.